TANTI SPUNTI TANTO IMPEGNO!
A Bologna, tra il 5 e il
7 maggio 2023, si è dipanata una densissima tre giorni intitolata "Reclaim the Tech, Officina di saperi e
pratiche per la giustizia digitale, sociale e di genere" nel Municipio
Sociale "Làbas" e nel
Centro Sociale "Teatro Polivalente
Occupato".
Chi lo ha organizzato non lo definisce come un semplice
"festival", bensì <<una fucina di scambi e riflessioni, un
percorso da costruire insieme per riprenderci la tecnologia e rimetterla al
servizio di persone e comunità>>.
Nei tre giorni si sono condensati tantissimi spunti
sulle tecnologie, in particolare quelle legate al mondo digitale: abbiamo preso
parte a una valanga di energia collettiva, abbiamo “immagazzinato” una riserva
di potenziale sociale e di voglia di fare, e siamo fiduciosə che all’ampiezza
di quelle riflessioni corrisponderà un impegno altrettanto “esteso”.
Questo articolo non è soltanto un “reportage atipico” e un
“ricordo” del festival, ma è soprattutto un post che parla di tecnologie,
specificamente quelle legate alle IT e con una particolare attenzione a una
serie di tematiche collegate alla strettissima attualità, con una serie di
“articoli nell’articolo”: parliamo quindi di tecniche di sorveglianza e
repressione di massa, social network “classici”, Fediverso, shadow-libriaries e Aaron Swartz,
algoritmi e AI, big data, cripto valute,
delle diaboliche dinamiche discriminatorie e voraci del capitalismo
di piattaforma e digitale e del contro-utilizzo delle sue meccaniche
Il nostro auto-inviato per nulla speciale, Scribha Kino
(detto anche Analfabeta Informatico Funzionale), è partito da Napoli
insieme a dei/delle “compa” per seguire l’evento, vediamo cosa ha
combinato...
RIAPPROPRIAMOCI DELLE “TECH”!
Sintetizzare cosa è stato il festival è per forza di cose uno
sforzo riduttivo: è difficile restituire il livello profondo delle riflessioni
e lo spessore delle elaborazioni teoriche... E sarebbe altrettanto limitante
considerarlo un mero festival, e non soprattutto un luogo dove intessere
relazioni e alleanze per progettare e mettere in pratica quello di cui si è
discusso negli svariati workshop e panel (più di 15), oltre che
negli incontri introduttivi e finali.
Per questo penso sia più utile (almeno dalla prospettiva di
questa Fanza/Rivista) raccogliere alcuni dei concetti che sono ricorsi più
volte e che penso sia necessario trasmettere “al di fuori” dei gusci virtuosi
delle varie militanze e dei vari attivismi.
Una ulteriore difficoltà nello scrivere questo “reportage”
deriva dal fatto che non ho particolari competenze “tecniche” in ambito informatico,
ma qui veniamo al primo punto fondamentale dell’approccio della “rete” del RTT:
i saperi e le persone specializzate in diversi tipi di conoscenza o di
studio non dovrebbero essere separati, ma anzi, dovrebbero “fondere”
le proprie capacità, incrociare diverse prospettive e attitudini per
progettazioni di tecnologie che siano il più inclusive ed efficienti possibile,
oltre a essere sganciate dalle logiche del profitto. In poche parole: i
diversi tipi specifici di “sapere” andrebbero integrati fra loro, e non
separati.
Chiunque potrebbe e dovrebbe partecipare ai processi
decisionali collegati agli aspetti tecnologici, e anche senza competenze
tecniche particolari potrebbe contribuire sviluppando utili riflessioni, anche
se credo che la diffusione di conoscenze basilari sul funzionamento dei
“calcolatori”, delle reti, e in generale delle più disparate tecnologie,
scienze e discipline, sarebbe comunque utile, così come è utile studiare la
matematica per far di conto piuttosto che avere nozioni basilari di filologia per comprendere cosa c’è dietro un testo.
Per questo sarebbe utile un ripensamento dei diversi percorsi
professionali e di organizzazione dell’educazione in chiave
"sincretica", oltre all’urgenza
della ridefinizione dei “ruoli” di chi si occupa, ma anche di chi
“subisce” le tecnologie, senza separare i “saperi”.
A nostra detta la tre giorni è stata molto proficua: non è
scontato parlare di tecnologia, nonostante la pervasività della dimensione
“post-umana” della società contemporanea, e lo è meno ancora avviare un
dibattito sulla ri-politicizzazione di queste, e in particolare su quelle digitali
(forse una differenza con i “classici” hackmeeting risiede proprio nel fatto che in un certo
senso la dimensione dell’elaborazione teorica e “filosofica” ha prevalso su
quella principalmente “tecnica”, anche se la cultura e una particolare
accezione dello stesso termine hacker può trascendere l’ambito
meramente digitale ed essere estesa a quello più generalmente tecnologico, ma
anche a chiunque che, “smanettando” con i problemi, riesce a trovare delle
soluzioni pratiche e degli stratagemmi negli ambiti più vari).
Le tipologie di “tech” che ricadono nel più vasto campo dell’Information
Technology sono infatti intrinsecamente connesse a una capacità che
distingue profondamente l’animale umano da tutti gli altri esseri senzienti: è
la possibilità di accumulare e tramandare conoscenza superando virtualmente (in
tutti i sensi) ogni barriera spaziale e temporale, e quindi in una parola la
nostra peculiare forma di comunicazione.
Workshop, panel, talk e presentazioni classiche si sono
affastellate in un turbinio di ispirazione per una concreta azione politica e sociale,
seguendo un “format” replicabile e riadattabile anche su base locale, e al
contempo andando oltre la dimensione “spaziale”, magari usando in maniera
virtuosa “l’online” (perché no!), e quindi organizzando degli eventi a distanza
o misti in presenza...
I gruppi e i singoli che hanno partecipato potrebbero essere
divisi in due categorie, di cui non facevano parte solo i “tecnici”
delle tecnologie in senso stretto, ma anche soggettività specializzate in
eterogenee sfere del sapere: da un lato ci sono le realtà, per così
dire, più “ribelli”, tendenzialmente antagoniste e militanti, come
centri sociali e collettivi politici. Al lato opposto potremmo collocare
diverse singolarità e gruppi della società civile, probabilmente alcuni
di questi sono meno “politicizzati” e forse più “istituzionali”, come le
associazioni del terzo settore, docenti e ricercatori accademici: la fusione
di questi due “mondi” è a nostro dire il principale punto di forza di
questo tipo di organizzazione (da estendere in tutti gli ambiti delle lotte
politiche e sociali!), perché mira a “riprendersi” la tecnologia e a “rubare
al padrone” gli strumenti essenziali per l’organizzazione delle nostre
vite, uscendo fuori dal “guscio” di militant@ e attivist@ anticapitalist@ (un
guscio che, a seconda dei punti di vista, può essere considerato a volte
virtuoso, a volte un po’ meno date le intrinseche problematiche di qualunque
processo “rivoluzionario” e di cambiamento), mirando a tessere alleanze
anche al di fuori dell’ambito marcatamente “sinistro”, più o meno radicale e
istituzionale, e quindi non dimenticando le complesse relazioni di
interdipendenza che ci legano tutt% e che ci legano al tutt%.
Il festival nasce dall’urgenza di ri-politicizzare il
dibattito sulla tecnologia digitale, di rimettere (o mettere per la prima
volta perlomeno in Italia) al centro del dibattito pubblico una serie
di questioni particolarmente urgenti , come quella di
<<denunciare le complesse catene di disuguaglianza innescate dal
capitalismo digitale>>, ha spiegato Lilia Giugni, docente
universitaria e autrice del libro “La rete non ci salverà, perché la
rivoluzione digitale e sessista”,
nonché un'organizzatrice di RTT e moderatrice dell’incontro di apertura (la
diretta registrata su Facebook si
trova qui).
Il tema del rapporto tra tecnologia, politica e diritti
umani sembra essere stato abbandonato, o quantomeno trascurato, non solo
dall’opinione pubblica in generale, ma anche da parte di tutte quelle
esperienze particolarmente impegnate in diversi contesti di lotta politica.
L’esigenza di tornare a occuparsi di “politiche tecnologiche”
e “diritti digitali” è particolarmente
urgente proprio perché, a detta di chi scrive, ne parliamo poco subendone molte
conseguenze, nonostante l'onnipresenza delle tecnologie (non solo quelle
digitali e “online”) nelle nostre vite, e nonostante siamo immersi nel pieno di
una nuova rivoluzione industriale.
 |
| L'incontro di apertura al Làbas |
Mentre entro nel vivo dei ricordi e degli spunti “accumulati”
in quelle 72 ore e sperando di riportarli nella maniera più corretta ed
esauriente possibile, vi faccio presente che qualora non riuscissi nel mio
intento potete sempre contattare la pseudo-redazione per qualunque richiesta di
correzione, critica, commento o proposta, anche nei commenti qui sotto. Questo maxi-post,
in linea con le “tattiche mediatiche” che caratterizzano la nostra linea
editoriale, contiene una serie di “articoli nell’articolo”, quindi
sfogliatelo e leggetelo con calma, magari anche “a pezzi”, e sperando di essere
in qualche maniera utile non mi resta che augurarvi buona lettura : )
CONSIDERAZIONI
GENERICHE SU DIRITTI DIGITALI E POLITICHE TECNOLOGICHE
Prima di scendere nel dettaglio di alcuni degli svariati temi
trattati, inizierei a parlare degli argomenti più urgenti sulle
tecnologie, e in particolare di quelle digitali e legate alle "reti",
che sono state al centro di questo fest nello specifico, insieme ad
alcune premesse basilari per comprendere sia lo spirito che lo ha
animato sia certe questioni della stretta contemporaneità.
Per prima cosa bisogna chiarire (casomai ce ne fosse bisogno)
che l’approccio alla tematica tecnologica condiviso da
organizzatrici/organizzatori e partecipanti non è di tipo “luddista”,
nel senso che non si prospetta un idilliaco ritorno all’età della pietra dopo
aver distrutto le “macchine infernali”, mentre invece si auspica un uso e la
creazione di tecnologie finalizzate al benessere dell’intera umanità, degli
altri esseri senzienti e dell’intero “habitat gigante” in cui siamo nat#.
Il punto di vista da cui l’iniziativa tenta di inquadrare la
riappropriazione tecnologica è riassumibile nello slogan “Dentro, Contro,
Oltre”: dentro i limiti personali e soggettivi, dentro le
contraddizioni generate dal sistema sociale vigente, mentre si cerca di essere
quanto più apert* possibile, schierandosi contro il potere, la violenza
e le prescrizioni di chi ci governa e delle multinazionali tecnologiche, con
l’obiettivo di andare oltre queste limitazioni per sperimentare
alternative di vita in maniera condivisa e senza imporre il proprio punto di
vista.
Passiamo poi allo stesso concetto
di tecnologia in senso ampio, e quindi considerando come tale anche
<<la ruota, oppure la forchetta>>, spiega Annalisa Pelizza, docente universitaria di studi sociali di scienza e
tecnologia, che ha una posizione chiara sui mezzi tecnologici in generale:
<<la tecnologia non è né buona né cattiva, ma nemmeno neutra>>,
e quindi resta alla collettività il compito di concepire e “direzionare” l’uso
degli strumenti tecnologici redistribuendo <<il lavoro morale che
evolve storicamente>>, e promuovendo modelli di ricerca e innovazione
responsabili e “responsabilizzanti”. Per fare ciò potremmo utilizzare,
rivisitandola, la nozione di contratto sociale, usata da secoli per
indicare quegli “accordi” collettivi miranti a superare lo “stato di natura”
per fondare un nuovo tipo di “stato”.
In parole povere il cruciale tema introdotto dalla docente
riguarda la ridefinizione dei ruoli, e quindi il “chi fa cosa”,
ma anche il rapporto tra <<tra tecnologia e scienza, e tra politica
e società>>: “reclaim” significa “reclamare”,
“rivendicare”, <<ma chi reclama la tecnologia>>?!
Sempre a proposito della “divisione dei compiti”, la stessa divisione tra
scienze “molli-umanistiche” e “dure-STEM” <<può essere molto
pericolosa>>, perché limiterebbe l’accesso alle conoscenze ai soli
“addetti ai lavori” (che siano informatici piuttosto che ingegneri o biologi),
insieme allo stesso dibattito su come progettare e usare le tecnologie.
Originariamente, negli anni ‘60-’70, l’ “high tech” era stato concepito per democratizzare
la società, con l’ispirazione e il contributo dell’immaginazione di
visionari, artisti, poeti, e scrittori dei decenni precedenti come Huxley,
Kerouac e Ginsberg, sognatori <<che volevano pace e
libertà>>, ma qualcosa è andato storto, ha argomentato Antonio Danieli della “Fondazione
Golinelli”. La potenza di calcolo e di “retenzione” di dati, insieme
alla velocità con cui questi sono trasmessi, sono talmente vaste da non poter
essere percepite tramite i nostri sensi, sono un qualcosa che sfugge ai limiti
biologici del cervello del creatore di quella macchina, <<l’uomo,
che si trova a essere in difetto, in potenza e in velocità, rispetto alla sua
creatura>>, il che comporta degli sviluppi altamente imprevedibili
dell’ hi-tech oltre a una difficoltà di adattabilità biologica e antropologica
di fronte allo spaesamento causato dall’ambiente “virtuale”.
Quella spinta “democratica” e “libertaria” è stata frenata
dagli sviluppi socio-economici delle meccaniche capitaliste già prima
dell’“era” dei big data, da poco
“inaugurata”: <<un conto è ideare, progettare, immaginare, produrre
l’hi-tech, un conto è utilizzare un prodotto e un altro ancora essere
utilizzati come prodotto>>. Arriviamo a un altro concetto tanto
attuale quanto cruciale (e probabilmente scontato): quando usiamo dei
servizi “gratuiti” come i social-network, stiamo in realtà fornendo dati che
permettono di profilarci per essere poi “venduti” noi stessi come dei prodotti
a chi ci bombarda di pubblicità per venderci, a sua volta, altri prodotti...
oppure peggio, per influenzare le nostre scelte elettorali, per esempio. In
sostanza sfogliando i “feed” dei social, mettendo “like” e anche postando
contenuti e commenti, volenti o nolenti e al di là dei messaggi che
divulghiamo, magari tentando di “combattere il sistema da dentro”, stiamo in
realtà lavorando gratis per le grandi multinazionali del “Big Thech”.
L’ingegnere Danieli parla poi delle “Intelligenze Artificiali” (abbreviate in A/I) prendendo in esame un concetto che si può estendere a tutte
le tecnologie basate sugli algoritmi in generale: <<l’intelligenza
artificiale è uno strumento che viene educato sulla base dei “big
data” che, come abbiamo appena detto e come oramai sappiamo un po’ tutti, siamo
noi. Quindi se l’intelligenza artificiale fa un qualcosa, o interviene, o cattura
un qualcosa di positivo o negativo, evidenzia e moltiplica quello che
intercetta nella società, e che normalmente magari non siamo in grado di
vedere, amplificandolo sia in positivo che in negativo>>.
Perciò è cruciale occuparsi di questi strumenti studiandoli,
costruendo e finanziando progetti di educazione e dibattito capillari, non solo
“istituzionali” ma soprattutto “autogestiti dal basso” e realmente partecipati,
inclusivi e non escludenti, per aumentare una consapevolezza finalizzata
alla riappropriazione delle tecnologie, con approcci multidisciplinari e il
contributo di <<poeti, filosofi, letterati ed artisti per immaginare,
insieme ai “tecnologi”, i prossimi passi>>. Bisogna combattere
passività e ignoranza, e non a caso il relatore cita una frase di Paolo
Benanti: <<più che l’intelligenza artificiale mi spaventa la
stupidità naturale>>.
CONSIDERAZIONI
“MATERIALISTE” E “INTERSEZIONALI”
Anche se non sono un seguace “sfegatato” delle tradizioni del
materialismo storico troppo vicine a un determinismo iper-semplicistico
(che probabilmente non spiega tutto ciò che è necessario per comprendere a
fondo e rivoluzionare le nostre vite, ma che comunque è utile per delineare un
orizzonte ideale verso cui tendere, oltre che per analizzare fenomeni
socio-economici), ci sono una serie di problemi strutturali, sociali,
economici, fisici, logistici e “materiali” che non possono essere assolutamente
messi in secondo piano.
Un punto chiave per comprendere come le tecnologie possono
contribuire a discriminare settori specifici della popolazione, e ovviamente le
comunità già marginalizzate, risiede nel fatto che l’“online” riflette una
serie di stigmatizzazioni che provengono dall’“offline”, e quindi si
innesca un circolo vizioso con degli algoritmi che rinforzano stereotipi,
essendo a loro volta alimentati da dati che riflettono quei pregiudizi nella
società “analogica”.
Un primo esempio concreto lo fornisce la giornalista Leila Belhadj Mohamed: <<io non
sono una tecnica nel senso tradizionale del termine. Non mi sono approcciata a
queste tematiche perché le ho studiate, ma perché sono una vittima di queste
tecnologie. Faccio un esempio molto concreto: oggi come oggi molti motori di
ricerca delle HR -Risorse Umane, ndr- sono costruiti con l’intelligenza
artificiale. Io ho un cognome straniero, io sono donna e razializzata, e ci
sono certi nomi che vengono cestinati in automatico. Magari il mio Curriculum
Vitae è identico a quello di un uomo bianco, etero e cis-gender con nome
occidentale, ma il mio verrà cestinato>> proprio perché la
tecnologia non è neutrale, ma riflette le intenzioni (anche in buona fede) di
chi l’ha progettata, pregiudizi inclusi.
Altri esempi calzanti sono legati alla fallacia delle tecnologie
di riconoscimento facciale, che in questi giorni il ministro Piantedosi sta
promuovendo: la giornalista e attivista transfemminista inizia citando il caso
“Gangs Matrix”, un database
utilizzato dalla polizia londinese per combattere le gang di strada, ma che in
realtà finiva per discriminare uomini solo per il colore nero della pelle (i
maschi erano il 99% nel 2018), soprattutto giovani (anche di 12 anni). Infatti,
secondo dati riportati da Amnesty International, il 78% degli “schedati”
erano di colore, mentre solo il 27% dei responsabili di atti di violenza
tra le “gang giovanili” avevano il colore di pelle nero (la ONG tra l’altro
mette in discussione lo stesso concetto di “gang”). I “sospetti” venivano
individuati da un algoritmo anche in base a dati come la musica che
ascoltavano, le amicizie sui social, il quartiere di provenienza, i vestiti che
indossavano (felpe con cappuccio), e ad altri provenienti dai database dei
servizi sociali nelle periferie, e quindi in
generale alla condizione socio-economica, per poi essere inseriti nel meccanismo
di riconoscimento facciale in attesa di potenziali crimini (in un clima
distopico alla "Minority
Report") e subendo controlli e perquisizioni ingiustificati, alimentando
stereotipi razziali e seminando sfiducia e sospetto, oltre a conseguenze drammatiche
nella vita reale come le ingiunzioni di sfratto e l’esclusione da percorsi
educativi, oppure la difficoltà nel trovare un lavoro, conseguenze che
riguardano anche le famiglie dei “registrati” nel sistema, senza trasparenza
sulla raccolta e sull’uso di quei dati.
Un altro esempio distopico di “polizia predittiva”, a
cui la collega ha fatto un breve cenno, è il cosiddetto “Sensing Project”,
sperimentato nella cittadina olandese di Roermond negli scorsi anni: secondo
Amnesty International una serie di telecamere e sensori servivano
a monitorare non solo le targhe di veicoli, ma anche tutti i guidatori e
passeggeri della cittadina, con l’obiettivo di identificare i sospettati di
commettere furti, ma per la ONG si tratta di una sorveglianza di massa
indiscriminata, ingiustificata e con una profilazione etnica a danno di
persone dell’est-Europa, e in particolare delle persone rom: <<le
autorità olandesi affermano che il sistema è neutrale e basato su dati
oggettivi riguardo ai crimini, a ogni modo Amnesty ha documentato che il
progetto è discriminatorio nel suo stesso design, che riflette preconcetti umani
integrati nella sorveglianza>>, ha detto la ONG in un comunicato di
due anni fa.
La giornalista nei pochi minuti del suo intervento tira fuori
molti altri esempi che dimostrano come le tecnologie sono degli strumenti che
diventano “cattivi” se sono nelle mani sbagliate o usati per fini perversi:
<<finché sono in mano agli stati democratici è una cosa, quando sono
in mano agli stati autoritari è un’altra>>, e per esempio in un paese
come l’Iran, dove i processi decisionali sono ancora più ristretti nelle
mani di poche persone così come sono ulteriormente limitati dei diritti
basilari, già dal 2019 i sistemi di riconoscimento facciale venivano usati per
riconoscere le donne che protestavano e che non indossavano il velo.
Poi c’è il caso dei <<primi
attivisti in Russia che sono stati arrestati dopo l’inizio del conflitto
in Ucraina, sono stati intercettati a casa, non nelle manifestazioni, perché
nella metropolitana di Mosca si accede con il riconoscimento facciale>>
con tecnologie statunitensi, permettendo di riconoscerli e di risalire
all’indirizzo della loro abitazione, e subendo non solo le “visite” della
polizia ma anche attacchi “fisici”, come nel caso di un manifestante cui è
stata spruzzata della pittura sul suo volto prima di ricevere anche una lettera
minatoria.
E ancora, <<quando gli Stati Uniti hanno
lasciato l’Afghanistan, hanno lasciato uno “stock” di dati biometrici
di persone che hanno collaborato con l’occidente>> e che dunque
rischiano persecuzioni.
Poi ci sono le persone trans o gender fluid che
vengono pesantemente discriminate perché, per esempio, la tecnologia non è in
grado di riconoscere una persona non-binary.
C’è lo strumento del “proctoring” che permette agli
studenti di sostenere esami online, ma previa <<luce sparata in faccia>>
per sembrare più “bianchi” ed evitare di essere bollati come dei “copioni”,
strumento originariamente costruito negli USA e che ha portato a una multa di
200 mila euro per la Bocconi comminata dal Garante per la Privacy
per diversi profili di illegittimità connessi al consenso e al trattamento dei
dati.
Ovviamente non dobbiamo dimenticare le “piattaforme”
possedute in larga parte da aziende private che fanno accordi con
diversi stati e che, a seconda dello stato e della specifica “policy”,
possono implementare strategie di censura o di propaganda che
consistono nel cancellare degli hashtag, <<anche se su questo, per
fortuna, l’Unione Europea è molto più avanti rispetto ad altri paesi (…) per
esempio in Israele TikTok è stato usato dal regime israeliano con
bellissime soldatesse che facevano i balletti ai check point con dietro i
bambini che venivano arrestati. Oppure parlare di Palestina su certe piattaforme
è praticamente impossibile: ogni 5 giorni finisco in shadowban se nomino
Iraq, Afghanista o Siria perché, in automatico, vieni “targetizzato” come se
stessi facendo proselitismo del terrorismo, anche se stai facendo
informazione>>, e questo avviene perché le piattaforme non riescono a
sviluppare dei sistemi che discernono i contenuti realmente “terroristi” da
quelli informativi, dalle testimonianze di chi coraggiosamente denuncia quanto
avviene in contesti di guerra, mentre è semplicemente più economico bannare
tutto.
Oltre alle questioni legate alla repressione e alla
propaganda, non dobbiamo dimenticare quelle intrinseche al sistema socio-economico capitalista e al
colonialismo digitale, <<dato
che abbiamo avuto un progresso tecnologico con un sistema economico e sociale
che è fermo all’800>>: prima avevamo lo sfruttamento
con persone che si spaccavano letteralmente la schiena, oggi abbiamo uno
sfruttamento di esseri umani davanti a uno schermo, come le persone sottopagate
nei paesi Africani e del “sud del Mondo” per “allenare” ChatGpt, oppure
che restano traumatizzate nel “filtrare” contenuti violenti e a sfondo sessuale
in modo che i “social” siano più “sicuri”, e che di solito lavorano per
compagnie terze, pagate in base a target giornalieri, senza godere di ferie e
di altri diritti.
Per questo bisognerebbe portare “ai tavoli decisionali”
<<soprattutto le persone competenti di quelle minoranze più
discriminate dalla tecnologia>>.
Per questo l’esperta di geopolitica e diritti umani, che è
anche attivista di “Privacy Network”, sottolinea l’importanza di promuovere consapevolezza e
pratiche di advocacy tra chi già fa attività sociali ma pensa che il
tema delle tecnologie non li riguardi: invece <<ti riguarda tantissimo
se ti occupi di immigrazione, se sei un collettivo transfemminista, ma anche se
semplicemente sei un collettivo di artisti indipendenti: si pensi al fatto che
il capezzolo femminile viene censurato nelle immagini mentre quello maschile
no... Bisogna creare delle sinergie sia con le istituzioni,
sia dal basso (...) spiattellando in faccia i problemi a chi si trova nei
“piani alti”>>, dato che accademici e ricercatori testano le
tecnologie scorgendo anche le possibili criticità, mentre “chi decide” di
solito si limita a firmare un atto, senza neanche comprenderlo nel peggiore dei
casi.
Va diffusa la <<conoscenza di "know-how">>
e quindi in generale la “conoscenza”, perché se <<la conoscenza
rimane privata, e io privato decido a chi e se venderla, è normale che quando
alcuni paesi non hanno le risorse economiche per acquistarla restano indietro o
finiscono vittime della tecnologia stessa>>. Serve <<l’educazione
alla digitalizzazione fin da piccoli>> oltre alla <<sinergia
e all’intersezionalità reale con
la creazione di tavoli su cui affrontare certe tematiche, servono tutti, tutte,
tutt’, servono le persone disabili, servono le persone trans,
servono le comunità razializzate, servono tutt’>> per
il superamento del <<maledetto sistema>> capitalista.
L’importanza della non parcellizzazione delle lotte
emerge anche dall’intervento nel panel sull’esclusione digitale di Valentina Tafuni, presidente
dell’associazione Hayat e attivista contro le diverse forme di
discriminazione, specialmente quelle delle persone
con disabilità. I modelli sociali imperanti riguardanti le
diverse abilità sono troppo spesso imperniati sulla “cura” e non sui diritti,
e cioè non inquadrano i diversamente abili come persone ma come “pazienti”,
affermando un’ottica “pietistica” in cui esiste solo la dimensione dell’“aiuto”
che non le fa emergere invece come protagoniste. Non a caso l’attivista cita lo
slogan della Convenzione ONU per i Diritti delle Persone Disabili, in
vigore dal 2008, che è anche un principio di auto-rappresentazione: “nothing
about us without us”, e cioè “niente su di noi senza di noi”.
Porta poi l’esempio di come lo “stigma della cura” viene messo in atto
anche quando ci sono degli obiettivi apprezzabili, ma non completamente
inclusivi e "protagonistizzanti": <<i grandi del tech stanno
portando varie iniziative in vari ambiti, anche in quello dell’accessibilità
delle persone con disabilità al mondo digitale. Per esempio Microsoft ha
lanciato questo“tech accellerator" per attivisti con disabilità all’interno del mondo per la cooperazione: può
essere un intento lodevole, però poi penso che il mondo della cooperazione
internazionale di per sé è un mondo che vede ancora le persone con
disabilità come destinatarie di azioni. Ci sono pochissimi cooperanti al
Mondo con disabilità e io vorrei essere, un domani, una di quelle, però mi
scontro con delle barriere di accesso anche in questo caso. Quindi -il
mondo delle “tech”- dobbiamo riprendercelo collettivamente, possiamo
togliere il monopolio se disegniamo insieme delle pratiche di cura e resistenza
partendo dai nostri mircro-sistemi, dai nostri micro-mondi e “connettendoli”
perché sono già connessi di per sé>>, perché siamo già
interdipendenti!
Tutt’ dovrebbero essere <<attori e attrici di una
cura collettiva e promiscua>> per contrastare l’abilismo così come è
necessario sconfiggere ogni forma di omobitransfobia, razzismo e sessismo, e
abbattere mentalmente la barriera del “diverso”.
Altri fondamentali spunti “riassuntivi” sono emersi
dall’intervento di apertura della già citata Lilia Giugni (consiglio vivamente di vederlo per chi non era al fest: magari smettete di
leggere questo articolo e ascoltate le
parole di quella “talk”, in cui sono condensati tutti gli aspetti basilari e le
principali istanze del festival).
La storia di Tiziana Cantone <<uccisa dal
capitalismo digitale>> nel 2016 è emblematica delle svariate vittime
create dal capitalismo di piattaforma
con i suoi business-model e le
sue strategie di monetizzazione, uniti alla cultura
patriarcale che ha permesso a un numero non quantificabile di
<<utenti di sentirsi in diritto di violare l’intimità di una donna, di
umiliarla per le sue celte sessuali>>, facendo diventare la violenza
digitale di genere (così come altre forme di odio e stigmatizzazione)
virale tramite la manipolazione dei feed
che non fanno altro che riproporre contenuti simili, in maniera da incollarci
allo schermo, estrarre più dati e aumentare il profitto, selezionando in
automatico e amplificando pregiudizi. Tiziana era diventata <<un
“fenomeno” della rete, dopo che alcuni suoi filmati intimi, di cui non aveva
assolutamente approvato la divulgazione, furono diffusi prima su alcune chat
Whatsapp e poi su siti di porn sharing (alla PornHub), diventando virali, in un
girone infernale. Piattaforme come YouTube e Facebook si riempivano di post, di
gruppi creati con il solo scopo di umiliarla e con Google che prontamente li
indicizzava, con i giornali nazionali che pubblicavano articoli con titoli
acchiappa-click in cui si rivelava nome, cognome,
città natale e indirizzo. Tiziana fu costretta letteralmente a scappare di
casa, a lasciare il lavoro, perché la gente la riconosceva per strada, a
rifugiarsi in un’altra regione, ad avviare un procedimento per cambiare
cognome, a tentare di portare in tribunale alcune di quelle piattaforme, senza
successo per poi alla fine, esausta, decidere di togliersi la vita>>.
Altra problematica materialmente basilare è quella legata al
“digital divide”, ossia al
divario tra chi ha accesso alle tecnologie e chi non può permettersele. Il
divario va colmato anche in senso culturale e formativo, e come attivistx,
nell’immediato e nel breve-medio termine potremmo costruire hacklab,
diffondere saperi ed esperienze in maniera orizzontale e dal basso cominciando
dai corsi di alfabetizzazione informatica, così come in moltissimi spazi
sociali esistono ambulatori, palestre popolari e corsi di lingua. Dovremmo
programmare iniziative come manifestazioni, flash-mob, incontri in piazza per denunciare
e contrastare le tecnologie del capitalismo di piattaforma e, nel lungo
termine, estendere questo tipo di istanze ad altri “campi di battaglia”
politica.
 |
| Due giovani “scroccano” il Wi-Fi di un fast-food durante la pandemia per fare i compiti perché a casa loro non potevano permettersi una connessione. La foto è emblematica del “divario digitale” ed è stata scattata in California, a pochi passi dal centro nevralgico del capitalismo di piattaforma e di “Big Tech”. |
Chi è più privilegiato quelle “tech” può permettersele perché
la loro costruzione materiale, prima ancora di come vengono progettati i
software, si basa sullo sfruttamento di
umani a danno di altri umani, di bambini che lavorano per una paga
giornaliera che corrisponde al costo di un nostro caffè, in delle miniere
(spesso tunnel e tuguri) per estrarre minerali e terre rare che macchiano di
sangue i nostri computer, telefonini, smartwach ecc. Quei materiali servono ad
assemblare le batterie delle auto elettriche e di altri dispositivi per avviare
una fantomatica sostenibilità e “rivoluzione green”, ma che di “green”
attualmente ha solo il “washing” (il “greenwashing” indica un ecologismo
fittizio usato per fare marketing dalle aziende che millantano di essere
rispettose dell’ambiente), dato che l’unico sviluppo realmente sostenibile non
si potrà mai avere all’interno di un sistema economico basato sulla crescita
infinita.
Arriviamo così al tema dello sfruttamento
dell’ambiente: quanto inquina inviare un messaggio su Whatsapp?
Quanta energia elettrica serve per postare la foto di un gattino carinissimo o
il meme con la celebrità del momento su Instagram, e come viene prodotta
quell’energia? Quanto inquina quel processo di estrazione dei materiali, senza
contare l’inquinamento “morale” che deriva dall’impoverimento di altri esseri
umani tramite il loro lavoro sottopagato? Le risposte sono facilmente
intuibili, almeno genericamente: inquiniamo tantissimo, non siamo
“sostenibili”! Decisamente più impegnativo è trovare le risposte che servono
per capire come non inquinare, come collettivizzare il potere delle tecnologie,
come evitare che l’essere umano abusi di altri esseri senzienti (a cominciare
da quelli della sua stessa specie), vegetali, e delle risorse non viventi, e
impedire la distruzione del pianeta.
Da questi disagi universali nasce l’esigenza di reclamare la collettivizzazione e la
socializzazione delle tecnologie, criticando chi sviluppa piattaforme e
infrastrutture capitalistiche, mirando a emancipare chi le “subisce”, sovvertendo
gli attuali assetti proprietari dei mezzi
di produzione industriali e, soprattutto, quelli culturali.
WORKSHOP SU COME PROGETTARE IL DISSENSO:
LABORATORIO DI MEDIA-ATTIVISMO E PRATICHE TECNO-POLITICHE A PROVA DI
CAPITALISMO DIGITALE
Cominciamo dal primo workshop cui ho preso parte, moderato da
Luca Recano, attivista del “Laboratorio di mutuo soccorso Zero
81”. Per prima cosa, facendo un po' di critica e auto-critica
(da partecipante), devo dire (stando anche a quanto ho sentito dire dai “compa”
che hanno partecipato agli altri workshop e panel) che forse alcuni gruppi di
lavoro sono assomigliati più a dei panel e viceversa, ma va benissimo così,
sono comunque più che soddisfatto e convinto della “riuscita” dell’evento.
Il workshop riflette la “duplice” natura ed esigenza del
fest, che consiste nel fare pressione sui decisori politici ma anche nel
creare “conflitto” per attaccare la logica capitalista amplificata dalle
tecnologie.
Partiamo dunque da quanto esposto, sia nel workshop che
nell’incontro introduttivo, da Emanuele
Braga, con un background “filosofico” al servizio dei <<processi
di lotta>> nell’ambito dell’attivismo e dei movimenti sociali.
La politica consiste in un processo della costruzione della
società, e quindi in una serie di rapporti di forza materiali che si
ripercuotono sulle tecnologie che per questo, come si è già espresso, non sono
neutre: il relatore viene <<da una traduzione operaista e movimentista>>,
e già dai primi tempi dell'avvento di Internet frequentava luoghi come i centri
sociali in cui, all'epoca, si respirava un fermento per il potere e il
potenziale emancipatorio di internet, dove si sperimentava il “D.I.Y.”,
acronimo di “Do It Yourself” e quindi
indicante l’auto-governo delle proprie vite i tutti gli ambiti.
Quell'aria si respirava << in ogni hacklab>>, ma poi qualcosa è andato storto,
quelle tecnologie sono state direzionate in maniera totalmente opposta... C’era
la sensazione che <<potevamo ridisegnare il Mondo>>, ma
<<l’unione tra sperimentazione sociale sul modello del creativo, e
quindi degli artisti, e la digitalizzazione dell’economia, il “web 1”, ha
praticamente trasformato le nostre vite in un disastro>>
perché essendo sempre connessi e “a disposizione” siamo finiti a lavorare 24
ore su 24, per non parlare della precarizzazione del lavoro causata dal mito
dell’essere “imprenditore di te stesso”, dal fare a gara a chi è il più
creativo, insieme a un abbassamento dei salari vertiginoso.
<<Dopo 10, 15 anni ci siamo trovati, dopo quella
fase “desiderante”, ad acquisire coscienza del fatto che siamo stati un
laboratorio per distruggere la redistribuzione sociale a mezzo del salario,
precarizzare il lavoro, ed essere sempre a disposizione h24 senza distinzione
tra tempo libero e tempo per il lavoro. Poi è arrivato il “web 2.0”, conosciuto
anche in letteratura con l’espressione “capitalismo di piattaforma”, per capirci
siamo nel periodo dell’avvento di Social Network come Facebook,
GAFAM,
logistica, housing di piattaforma>> e quindi le piattaforme come AirBnb ecc.
In quel momento ci si è accorti, con una frase molto in voga,
che “il vero petrolio sono diventati i dati”, e quindi inducendo
l’immissione ed estraendo i dati dei “prosumer” (consumatori e fruitori allo
stesso tempo) si attivava il meccanismo di <<finanziarizzazione del
sociale>> nella cornice di un “capitalismo di piattaforma”
che è anche un “capitalismo di sorveglianza”, innescando tra militantə e
attivistə una discussione su come si crea “autonomia digitale”, <<come
si fa a non essere predati dei nostri dati>>, come dobbiamo
proteggere la nostra privacy e quindi <<come non alimentare quel
processo di valorizzazione che non veniva redistribuito dal monopolio
finanziario e che andava sempre più concentrato in quei monopoli>>,
oltre all’aspetto di come i nostri comportamenti, desideri e corpi vengono influenzati, di come viene disegnato
il consenso: <<sostanzialmente siamo
diventati delle protesi fisiche di algoritmi che decidono sui nostri tempi
di attenzione, sulle nostre energie, oltre al disegno sociale che c’è dietro>>.
Si è quindi cominciato a studiare come si creano relazioni,
elaborando degli “algoritmi del comune” nelle pratiche “analogiche” come
le assemblee, per comprendere i nostri desideri e a che cosa <<vogliamo
dare il consenso>>, <<perché non c’è una soluzione tecnica
al “politico”>>, questione che si è tentata di risolvere con
strumenti come le blockchain che servivano a decentralizzare il potere
capitalista ma poi, l’esempio di Bitcoin nell’era del “web 3”
purtroppo lo conferma, sono diventati dei potenti strumenti speculativi della finanza
tecnocratica (in maniera paradossale, per uno strumento che doveva rompere
il monopolio della moneta, e che forse già nell’ideazione iniziale era
programmato in tal senso, mi sentirei di aggiungere) che consumano ingenti
risorse ambientali con il data-mining, proprio perché si è
sottovalutata <<la sfida politica cadendo nel primato del “tecno-soluzionismo”>>,
e quindi la vera sfida dovrebbe essere capire “cosa vogliamo?!”.
A questo proposito il ricercatore e artista-attivista
snocciola poi una serie di esempi di forme di autorganizzazione e di
“dissenso digitale”, e ha spiegato che è in cantiere la pubblicazione di
una sorta di “timeline” per tracciare una genealogia di esperienze accomunate
da un rapporto dissidente con la
tecnologia, in collaborazione con il Museo
Reina Sofia di Madrid:
cominciamo dai progetti incentrati sulla “cura”, o per
dirla all’inglese sul “care”, <<degli esperimenti situati tra
l’analogico e il digitale, tra l’online e l’offline, che si pongono prima di
tutto il problema politico di necessità esistenziale, economica, di reddito,
ecc., per poi trovare delle soluzioni mentre si divertono a disegnare un “algoritmo”>>
che non necessariamente è “digitale”.
C’è il progetto “The Hologram” nell’ambito
della cura “peer to peer” (letteralmente in italiano “paritetico”,
abbreviato in P2P, e che nel linguaggio informatico indica una rete distribuita
e decentralizzata) ideato dall’artista Cassie Thornton. È una sorta di “algoritmo
analogico” che in concreto si traduce in un gruppo di ascolto dove
tre persone (che si riuniscono online o in presenza) si prendono cura di una
quarta considerando tre aspetti della sua vita: quello fisico/medico, quello
psicologico/emozionale e quello sociale/economico. Particolare attenzione viene
posta su queste tre dimensioni della persona curata, come in un “ologramma”
multidimensionale, invece che considerare quella persona come “merce” per
l’industria medica.
Nel percorso vengono dati dei consigli che poi, quando la
quarta persona è pronta, darà a sua volta in un nuovo “triangolo”, innescando
un meccanismo simile a quello di una catena di Sant’Antonio.
Il progetto socio-sanitario informale e femminista si ispira
al movimento delle “Cliniche della Solidarietà” in Grecia.
Per ovviare alla crisi del concetto di “cura” ci sono anche
le iniziative, i workshop, i sondaggi e i metodi elaborati di “Pirate
Care”, una rete di attivisti, accademici, professionisti impegnati in
un progetto di ricerca sulle pratiche collettive di muto aiuto e solidarietà.
Scopo iniziale del progetto era quello di “mappare” questo genere di esperienze
e collettivi, per poi in un secondo momento acquisire conoscenze al fine di
espandere questo genere di prassi legate al “care”, duramente attaccate e
disincentivate dalle logiche neoliberiste: ci sono quelle contro la
criminalizzazione della solidarietà e le brutalità della polizia, così come
quelle in favore al diritto all’abitare e per superare le politiche
razzializzanti, oltre che quelle per politicizzare la “pirateria”, restando nel
campo tecnologico.
Poi ci sono i <<percorsi
di sabotaggio di queste maledette piattaforme del capitale
con delle comunità che hanno trovato il modo di rubare i soldi, laddove
si concentrano, per poi creare degli schemi
di redistribuzione
economica che permette loro di pagare gli affitti o di avere reddito in posti
completamente precarizzati ed economicamente depressi fregando Spotify>>
e altri colossi del capitale digitale (a tal proposito è stato menzionato un
gruppo di italiani che avrebbe elaborato uno schema per aumentare
esponenzialmente gli ascolti sulla piattaforma di musica e podcast, creando un
reddito “artificioso” tramite canzoni brevi e inventando il genere della “Short
Wave”: online non abbiamo trovato tracce di questo gruppo nostrano, ma
nelle cronache è menzionato il caso di un cittadino americano che usava dei bot
per aumentare visualizzazioni e incassare una cospicua percentuale sui diritti
d’autore, “esperimento” che però è fallito con Spotify che gli ha fatto
anche causa per truffa).
Restando nel paradigma “Robinhoodiano” e passando nel campo
della finanza c’è <<un progetto che facemmo nel 2005 con dei compagni
finlandesi che si chiama Robin Hood Minor Asset Management: era un
algoritmo parassita che copiava i comportamenti degli hedge fund>>, noti anche come “fondi
speculativi”, che <<gestiva un fondo cooperativo che avevamo
costituito, e lo usavamo per creare una sorta di finanziamento per l’attivismo
mondiale>>. In pratica dopo aver sottratto linfa finanziaria ai
grossi “pescecani” e seguendo le loro stesse strategie, quei fondi venivano
destinati a diversi progetti di attivismo.
Tra i vari <<schemi che sono un enorme campo di
sperimentazione>> ci sono le “Alt-Coin”
legate al paradigma della “Moneta del Comune”, alternative al Bitcoin, per tentare
di impiegare le logiche alla base delle cripto-valute nelle economie circolari e solidali.
Costruendo valute per un modello economico alternativo si supera la
stessa natura della prima cripto-valuta della storia, di cui era prevedibile il
suo uso da parte del grande capitale finanziario, utilizzando soluzioni
“tecniche” che in realtà sono molto più semplici e praticabili
rispetto a quelle promosse dai circuiti mainstream, pubblicizzate tramite l’“hype”
connesso al machine learning e alle blockchain.
Tra questi modelli di attacco frontale al capitalismo
finanziario attuato “da dentro il sistema” per crearne un altro che si
sviluppa “dal basso”, spicca sicuramente l’esperienza “Robinhoodesca” di Enric
Duran Giralt, attivista catalano che “scroccò” quasi mezzo di milione di
euro in prestiti da più di trenta banche spagnole senza nessuna intenzione di
restituire il denaro, ma volendolo invece reindirizzare verso diversi progetti
solidali e anticapitalisti. La sua vicenda è direttamente connessa allo
sviluppo di FairCoin, a sua volta legato a FairCoop
e a Bank Of The Commons, dei tentativi di sviluppare sistemi
bancari, monetari e cooperativi alternativi ai modelli vigenti.
Oltre alle esperienze nel segno di “rubare ai ricchi per
redistribuire tra i poveri”, legate agli aspetti finanziari del dissenso
digitale, ce ne sono altre legate a svariati ambiti dell’agire umano e che
apportano un impatto positivo: per esempio c’è la piattaforma Basic Income Network per aggregare idee sul reddito minimo universale; oppure Dyne.org,
fucina interdisciplinare no-profit di software
libero (da non confondere con il concetto di open source);
e ovviamente degne di menzione sono anche esperienze di mediattivismo come Tactical Media
Crew e Indymedia.
Restando nell’ambito “medium”, ci sono gli esempi delle
cosiddette “Shadow Libraries”
(Sci-Hub, Monoskop, Memory
of the World, LibGen, il motore di ricerca Anna’S Archive ecc.) <<un patrimonio
incredibile di lavoro, manutenzione e messa a disposizione di accesso libero
attraverso la rete>> che operano in un’area tra il “grigio” e il
“nero” e quindi, a seconda dei casi, tra la potenziale o la palese violazione
dei diritti di autore e di utilizzazione economica in particolar modo di contenuti scientifici e accademici: la conoscenza
è potere, un potere che si acquisisce anche perché alcune parti del Mondo e
alcune classi sociali sono “privilegiate di default”, e distribuire più
equamente questo potere, condividendo in maniera libera risultati di studi e
ricerche, oltre a essere eticamente auspicabile potrebbe aiutare la
collettività globale nel trovare soluzioni ai problemi dell’emergenza
ambientale, o magari per trovare nuove cure mediche, ecc...
Invece molti di quei contenuti vengono strapagati più
volte ai grandi colossi editoriali: li paghiamo con le tasse
tramite onerosi accordi con le istituzioni accademiche, che si trovano a pagare
sia gli editori (e monopolisti/oligopolisti culturali e del sapere scientifico)
sia chi fa ricerca: in pratica le università pagano chi fa ricerca e poi pagano
nuovamente per l'accesso alle ricerche finanziate da loro;
li pagano gli stessi autori di studi e ricerche
(in particolare quelli “emergenti” e meno noti) per poi magari ricevere solo
“briciole” di profitto o addirittura rimetterci se le copie restano invendute,
dopo anni di sforzi (e in tanti casi di precariato) che vengono in larga parte
“sacrificati” in favore delle piattaforme che pubblicano, invece che per sé
stessi e per l’intera comunità;
e poi li pagano i singoli, studiosi e ricercatori ma
anche “comuni lettori mortali”, quando se lo possono permettere, restringendo
dunque la possibilità di contribuire al progresso dell’intera umanità solo a
chi è già privilegiato, un progresso (a detta di chi scrive non certo lineare)
basato a sua volta sull’accumulazione di conoscenze nei secoli, conoscenze che
andrebbero collettivizzate anche per essere conservate e tramandate meglio.
Forse le energie, i costi e i proventi derivanti e impiegati
nell’archiviazione e nella revisione dei materiali di studio (e
quindi quello che si definirebbe il “controllo qualità”) dovrebbero
essere sganciate dalla logica del profitto privato ed essere lasciate al
settore pubblico (cosa che dovrebbe essere naturale quando quelle ricerche sono
finanziate dal pubblico prima di essere “strumentalizzate” dai privati) e ai
volontari (oltre che agli stessi autori “vincolati” da accordi commerciali
iniqui) che attualmente sono “costretti” dal sistema editoriale a operare
nell’illegalità (difficilmente credo che tutt* i/le volontari/e siano dei "pirati”
assetate/i di soldi ma anzi, immagino che la maggiorparte siano assetate/i di
giustizia sociale).
In più tutti i volontari “pirati” stanno assolvendo al
compito di preservare la conoscenza, mentre rischiano ripercussioni
legali e di altro genere: se per caso i “server”, e quindi in soldoni i
computer, su cui sono salvati le poche copie digitali di un documento,
dovessero essere danneggiati o distrutti (un po’ come successe per la mitica Biblioteca
reale d’Alessandria), sarebbe impossibile o più difficile recuperare quei
lavori, quei pezzi di conoscenza. Invece se venisse facilitata e incentivata
una diffusione capillare di quelle conoscenze sarebbe anche più facile
conservarle e tramandarle.
Inoltre c’è un’altra questione, probabilmente ancora più
rilevante per gli impatti immediati sulla comunità umana, che non riguarda i
ricavi immediati del mercato editoriale ed è associata al fenomeno umano della corruzione:
privati e colossi dell’editoria potrebbero usare il “potere delle conoscenza”
per favorire altri privati “distorcendo” i risultati delle ricerche, incentivando
soprattutto quegli studi che generano ulteriori profitti per pochi e danni per
molti.
Per esempio potrebbero essere favoriti gli studi che
affermano come un determinato processo di produzione non sia poi così
inquinante come si crede, o magari che gli effetti collaterali di un certo
medicinale non siano poi così cattivi. In parole povere potremmo definire il
fenomeno come “corruzione accademica”, una questione su cui
l’hacktivista Aaron Swartz stava
lavorando: si ritiene che l’inchiesta giudiziaria che ha portato al suo
suicidio nasceva in realtà da un’“indagine” del cofondatore di Reddit su un database di pubblicazioni
accademiche in tal senso, piuttosto che dalla sua fantomatica intenzione di
arricchirsi o dall’ipotesi intermedia di “piratare” contenuti per
redistribuirli alla “Robin Hood” nei paesi saccheggiati dall’occidente, e
dunque poveri (se ne parla al 53esimo minuto del documentario/inchiesta “The Internet’s Own Boy” , spiegando che in precedenza Aaron scaricò più di 400mila articoli per
indagare, insieme all’avvocata Shireen A. Barday, su chi finanziava studi
giuridici con il fine ultimo di ottenere un trattamento più vantaggioso a
processo).
Bisognerebbe favorire la collaborazione tra ricercatori,
accademici e non, invece che fomentare una competizione esasperata che consiste
in una gara a chi fa “più punti” (e cioè a chi pubblica di più e con
editori più “prestigiosi”, o a chi “vende” di più inserendo i propri testi nei
materiali d’esame, magari per “rientrare” nei costi sostenuti in una sorta di
“self-publishing accademico”).
Aaron Swartz era anche l’autore del Guerrilla Open Acces Manifesto: invitava alla disobbedienza civile, non solo scambiando password e
scaricando articoli per conoscenti e colleghi, ma anche “piratando”
contenuti scientifici per ridare conoscenza, e dunque potere, pure agli
studenti del Sud del Mondo, spiegando che non è giusto rispettare delle leggi
palesemente inique che equiparano la condivisione della conoscenza al<<saccheggio
di una nave e all’omicidio dell’equipaggio>>. Se un numero
sufficiente di persone avesse seguito il suo invito, diceva, la “privatizzazione
della conoscenza” sarebbe stata solo un ricordo del passato. Brecht diceva
che “quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa un obbligo”
e tutti noi, specialmente chi segue delle regole sapendo in cuor suo che queste
sono profondamente immorali, dovrebbe farsi qualche domanda in più sul rapporto
tra moralità e legalità, e agire di conseguenza (come minimo ingaggiando delle
“battaglie legali”, non solo in tribunale, se non si può o non si ha il
coraggio di ricorrere alla disobbedienza civile ed esporsi a ripercussioni
legali e di altro genere)...
Dopo aver trattato di diversi esempi di dissenso verso il
capitalismo digitale, la presentazione di Simone Robutti , informatico che
ha <<smesso di progettare software per iniziare a scrivere progetti>>,
ha intaccato la nozione classica e il tabù della “leadership”, proponendone un nuovo “archetipo”: negli
ambienti della sinistra radicale, e in particolare in quelli libertari, la
definizione classica di “comando” e “direzione” viene vista con sospetto, dato
che istintivamente fa venire in mente l’autoritarismo e il trauma storico della
gestione gerarchica del potere nel’URSS. Il concetto di leadership dovrebbe invece essere rielaborato,
e quindi superato, intendendolo come una proprietà da distribuire tra i
gruppi di persone il più equamente possibile, dato che è praticamente
inevitabile che alcune identità emergano più di altre: per esempio in
un’assemblea strutturata orizzontalmente certe individualità potrebbero
“sovrastarne” delle altre perché hanno una maggiore conoscenza di una tematica,
oppure semplicemente perché sono più propense a parlare in pubblico e meno
timide, facendo emergere quelle dinamiche di potere che si cerca di
contrastare.
Inoltre favorire delle forme di leadership è cruciale nei processi
di responsabilizzazione in cui tuttə si assumono la responsabilità di fare
qualcosa: se davvero “nessuno” fosse leader, chi si prenderebbe l’impegno di
portare a termine un determinato obiettivo, anche senza “comandare” altrə (o sé
stessə)? L’orizzonte ideale è quello in cui tuttə si impegnano e sono
“leader”, ma per tendere verso questa visione è necessario <<un
cambiamento non solo organizzativo, ma culturale, sociale e spirituale>>
in cui il/la leader non è chi dà un ordine, ma in cui tuttə lo sono in forme
diverse.
 |
| Nello schema in foto l’attivista mostra una possibile schematizzazione di diversi tipi di personalità e le rispettive caratteristiche, una ripartizione teorizzata da Starhawk. |
Nell’ultimo intervento Ciro Ogliastro di Etica Digitale,
<<gruppo volontario indipendente di ragazzi e ragazze con l’intento di
riportare la persona e i diritti al centro del dibattito tecnologico>>, ha parlato di diverse questioni "storiche" riguardanti l'uso dei nostri dati da parte delle "big" del tech, e ha introdotto il concetto di Fediverso, un’alternativa
ai classici “Social”.
L’etimologia del termine deriva dall’unione di “universo” e
“federato”, un universo fatto di diversi social network che in qualche maniera
“ricalcano” la struttura di quelli mainstream.
Le differenze con questi sono però molteplici e sostanziali:
in primis non sono delle “piattaforme” accentrate nei server di
un’azienda privata, ma sono dei protocolli basati su linguaggi aperti,
comuni e personalizzabili, e i server su cui sono ospitati i dati sono diffusi
e quindi decentralizzati. Sui vari tipi di social-network
decentralizzati, di cui probabilmente Mastodon che rassomiglia a Twitter
è il più famoso, si possono creare delle “istanze” con regole che
vengono decise dalla community o da chi le fonda, ed è anche possibile seguire
profili di istanze diverse o “trasferirsi” senza perdere i propri “toot”
(il corrispettivo dei “tweet”) nel caso di Mastodon. Inoltre i diversi “social
federati” possono essere connessi tra loro senza dover per forza aprire un
account su ogni “protocollo-piattaforma” (in pratica sarebbe un po' come poter seguire un account su Instagram da Twitter). Gli algoritmi di solito
sono molto semplici, e includono nei “feed” i contenuti dei profili con
cui si è connessi in ordine cronologico, mentre gli algoritmi diabolici dei
social “classici”, basati su meccanismi
di raccomandazione, propongono contenuti sponsorizzati e “di successo” in
“feed” virtualmente infiniti da scrollare, con l’obiettivo di monopolizzare il
nostro tempo (che come le risorse sul pianeta è limitato, in opposizione a un
modello economico di “sviluppo” infinito) insieme alla nostra attenzione per
accumulare dati e renderci “il prodotto”, inchiodandoci allo schermo con
meccanismi molto simili a quelli impiegati nelle "macchinette" dei
videopoker e nei videogiochi altamente “addictive”.
Anche per questo si possono utilizzare una serie di pratiche
come il “detox digitale”(che potrebbe culminare in un vero e proprio
“boicottaggio” di questi), che consiste nel prendersi delle pause più o meno
lunghe dai social e programmando un uso sapiente di questi strumenti,
funzionale al nostro tempo, ai nostri obiettivi, e cercando di “eludere” i
contenuti che ci vengono propinati in automatico selezionandone di altri.
Banalmente, anche nel Fediverso potrebbero svilupparsi
fenomeni di centralizzazione e di polarizzazione all’interno di
“bolle informative” (ossia veniamo indirizzati o ci auto-indirizziamo verso
contenuti della “bolla ideologica” cui apparteniamo, rafforzando le nostre idee
e non aprendoci al “diverso”) e non è un caso che perfino Donald Trump ha
avviato “Truth Social” partendo dal codice di Mastodon. Nei vari
"nodi" del Fediverso potrebbero trovarsi una serie di profili “troll”
che veicolano contenuti tossici, oltre alla potenziale trasformazione in
“Grande Fratellino” di chi controlla materialmente i
server, sfruttando i dati che circolano sui PC usati dagli amministratori per
il funzionamento di un’istanza:
anche in questo caso le dinamiche “orizzontali” di progettazione,
controllo e “cura” sociale, che richiedono una certa dose di “protagonismo” e
molti sforzi pagati (al più) solo dalle donazioni, insieme alla semplice
possibilità (non attuabile sui social tipici) di abbandonare, creare ex novo o
criticare istanze, possono essere una risposta a queste problematiche.
Altre considerazioni sul Fediverso e su come usare
“sapientemente” e “in maniera alternativa” i social tradizionali, sono emerse
anche in un altro panel di Open For Future: quando
si vuole promuovere un contenuto, un collettivo o una “battaglia”, si può
scegliere di avere una presenza “tattica” su tutti i social mainstream,
cercando allo stesso tempo di far uscire gli “utenti” da quelle piattaforme.
È una questione molto spinosa proprio perché imprese come Facebook
e "Big G" hanno di fatto monopolizzato la “visibilità” di una
qualunque attività, per cui diventa molto difficile “farsi conoscere” o
semplicemente comunicare la propria esistenza senza passare tramite i loro
canali.
La strategia comunicativa potrebbe perciò consistere nel
classico “siamo presenti sui social” per poi veicolare contenuti che
“dirottano” l’attenzione verso iniziative di vita reale o verso il Fediverso.
Oppure si potrebbe scegliere, in maniera più radicale, di dire che “non siamo
presenti sui social, non ci mettete i like perché non ci importa e li
boicottiamo, incontrateci dal vivo”...
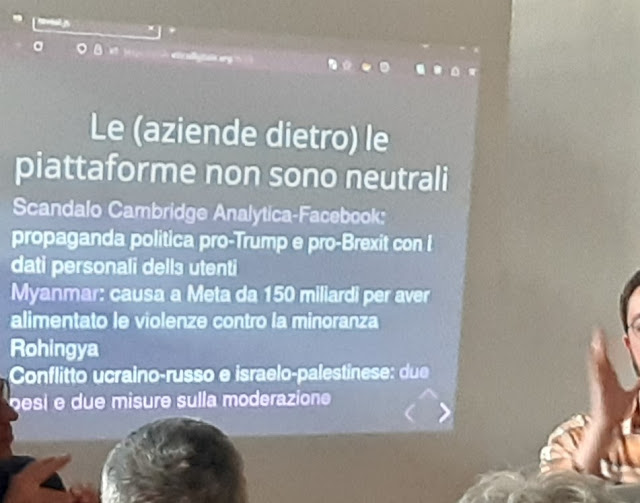 |
| Alcune vicende "storiche" sullo sfruttamento dei dati per fini politici, come il noto caso di Cambridge Analytica |
Infine c’è Bonfire, di cui si è parlato in uno dei workshop conclusivi, che è un “ambiente
social” e pezzo del Fediverso altamente personalizzabile con molti ambiziosi
obiettivi, tra cui quello di creare un ambiente che non sia solamente “non
tossico”, ma addirittura “terapeutico”, in particolare con delle forme
di controllo “positive” di chi ha particolari fragilità e dei/delle più
piccole/i da parte di genitrici/genitori e tutrici/tutori.
Nel video
si nota una riproduzione dello spazio “Làbas” tramite Minetest,
software libero alternativo a Minecraft del colosso di Microsoft:
tra i curatori del “mondo a cubi” aperto e libero c’è Marco Amato di Etica
Digitale.
Concludiamo questo paragrafo con una considerazione da tenere
bene in mente e che di solito riguarda molte delle esperienze “di conflitto”
e auto-gestionarie, così come quelle di “advocacy” e di pressione più
“riformista”, qualcosa che non possiamo non considerare come militantə e
attivistə: esperimenti e pratiche di questo genere da un lato potrebbero
essere troppo marginali e ridotte dal punto di vista dell’espansione al di
fuori dei circuiti delle militanza, ma anche da quello del sostentamento
economico. Mentre dall’altro potrebbero essere fagocitate dalle logiche
e dagli operatori del “mercato” o dalla politica con la “p” minuscola,
ossia quella tendenzialmente partitica e/o “cialtrona”...
PANEL SU TECNOLOGIA, SORVEGLIANZA E REPRESSIONE: DALLE
CARCERI AI CONFINI
Tra gli svariati incontri abbiamo deciso di prendere parte al
panel moderato dal giornalista Lorenzo Guadagnucci, in cui le tecnologie
erano messe in relazione con le tematiche della detenzione e della criminalizzazione delle persone in movimento, oltre a chi è
solidale con loro, due temi che non
a caso ricorrono spesso tra le pagine di questa Fanza/Blog/Rivista.
Ad aprirlo ci sono gli interventi di Ilaria Giugni e Francesca Bonassi, esperte di diritto e operatrici dell’Associazione
Antigone presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli.
Condividiamo pienamente l’orizzonte ideale abolizionista dell’istituzione penitenziaria che andrebbe ripensata radicalmente e
“hackerata” in senso politico/legale, un’istituzione
che è anche “tecno-repellente”: la
mancanza di fondi e risorse per avviare le attività che servirebbero alla
“rieducazione” dei/delle ristrette/i si ritrova anche nel settore tecnologico,
incrementando ingiustamente il grado di afflittività insito nella stessa pena e
incidendo sui diritti di quegli esseri umani, violazioni
di diritti al centro del loro intervento. Violazioni che nel caso di
donne e madri vengono amplificate dall’ulteriore stigmatizzazione per l’essersi
“macchiate” di un’azione ritenuta illegale in quanto generatrici di un essere
vivente, e non come “semplici” donne.
La scarsità di questi mezzi e l’assenza di tecnologia nelle
“quattro mura”, in una società “iperconnessa” in cui il confine tra virtuale e
reale si assottiglia sempre di più, si traduce in un’ulteriore “contenzione
virtuale”, dato che una serie di strumenti sono oramai indispensabili
per qualunque attività lavorativa o di studio
(e non parliamo di garantire l’accesso ai social network per postare trivialità
ma, banalmente, a un programma di videoscrittura e a materiali di studio su dei
CD, oltre che a connessioni “protette”, cose che almeno “sulla carta” sono programmate da più di vent’anni),
alimentando la distanza siderale tra le dimensione del “fuori” e quella del
“dentro” e negando la possibilità di emanciparsi... e quindi, in ultima istanza,
sostenendo il circolo vizioso della recidività invece che innescare
quello virtuoso di una presunta “rieducazione”.
Un effetto parzialmente positivo della tecnologia nell’ambito
del diritto all’affettività deriva
dall’utilizzo delle video-chiamate a distanza che in molti casi, in particolare
per i migranti o per chi ha familiari in luoghi distanti, costituisce l’unica
via di comunicazione con i propri cari. Questo metodo di comunicazione dovrebbe
comunque essere “accessorio” e non il principale, e bisogna ricordare che
l’Italia è molto indietro ad altri paesi dove periodicamente vengono previste
delle visite “private”, “intime”, mentre negli istituti nostrani l’affettività
fisica è completamente negata o relegata a un surrogato di sporadici
“tocchi” o “abbracci” durante le visite.
Tuttavia le operatrici hanno denunciato una serie di casi in
cui perfino la privacy delle video-chiamate viene calpestata: vengono
effettuate in luoghi non consoni come corridoi o addirittura all’aperto e al
freddo oppure, peggio, non ci sono abbastanza strumenti per farle proprio
perché magari la batteria del cellulare si scarica... E hanno anche raccontato
di due casi paradigmatici: la storia di Vincenzo che è stato trasferito in
Sardegna e con il padre disoccupato che può visitarlo solo una volta all’anno,
e quella di Svetlana rinchiusa da 22 anni dopo che ha ucciso il suo
“protettore” che non ha mai fatto nemmeno un colloquio.
Altra storia paradigmatica, legata però al diritto allo studio, è quella di Anna, che
sta studiando economia in DAD presso il Polo Penitenziario della Federico II:
non può certo seguire le lezioni quando ne ha bisogno, ma solo per “gentile”
concessione dell’autorità giudiziaria, o per meglio dire <<quando
vuole la penitenziaria>> che deve registrare tutto. Inoltre,
paradossalmente, l’acceso alla DAD è permesso solo per i corsi che si tengono
nella stessa regione.
E ancora: quando una detenuta viene trasferita in un altro
istituto i dati che la riguardano, come le presenze a lezione, vengono registrati
dalle maestre elementari su un foglio di calcolo elettronico che però non sono
trasferiti verso gli istituti di destinazione, e quindi la ristretta dovrà
sostenere nuovamente il percorso di studio.
Altro esempio dei paradossi dei diritti “tecnologici” negati
è quello di una detenuta per piccoli reati. Le relatrici ricordano che lei,
come tutti i detenuti che non avranno diritto alla "remissione del
debito", oltre a dover pagare le spese per il suo mantenimento in
carcere dovrà patire le conseguenze di un errore di un centro fiscale che
le ha permesso di ottenere i pochi spicci previsti dal reddito di cittadinanza.
Le operatrici avevano trovato un articolo online che poteva esserle utile ma la
consegna le è stata negata “in quanto scaricato da internet”...
Queste mancanze “digitali” si ripercuotono ovviamente anche
sul diritto al lavoro, e quindi sulla
possibilità di “telelavoro” e di formazione a distanza, e dietro le sbarre
prevale ancora la dimensione manifatturiera.
Il diritto su cui è fondata la nostra Repubblica, che di
fatto si regge più che altro sul precariato disattendendo quanto previsto dal
primo articolo della Costituzione, in carcere può trasformarsi in un vantaggio
sostanziale in favore del capitale: la popolazione carceraria è infatti anche
una “riserva di manodopera” particolarmente preziosa, dato che chi è
“dentro” ha meno da fare e quindi è anche maggiormente incline a lavorare
“stacanovisticamente”, oltre a essere meno propenso a far valere i propri
diritti.
Le esperienze e l’intervento del sociologo Valerio Pascali, membro del direttivo
regionale Emilia-Romagna di Antigone,
confermano le ampie lacune del sistema penitenziario che percorrono tutto lo
Stivale.
In più, in qualità di ricercatore, ha portato un altro
esempio dei bizantinismi burocratici
del sistema penitenziario che hanno ostacolato la sua attività di studio:
mentre faceva una ricerca etnografica di tipo qualitativo nel carcere padovano Due
Palazzi gli è stato vietato di entrare con qualunque dispositivo per registrare,
perfino quello con le cassette a nastro. Si è perciò ritrovato a dover
trascrivere a mano le interviste con i ristretti, compromettendo la qualità del
dato raccolto.
Altro punto che ha toccato è quello del ruolo della
tecnologia in relazione alla sorveglianza interna. Ha ricordato che
nelle rivolte scoppiate nei primi giorni dell’emergenza pandemica nel carcere
di Modena (in cui sono morte 9 persone in totale, alcune sul posto e altre
nell’immediatezza dei trasferimenti disposti) il mancato funzionamento delle
telecamere di sorveglianza non ha permesso di fare chiarezza sui punti oscuri
della gestione della sommossa, a differenza di quanto avvenuto invece a S.
Maria Capua Vetere, dove c’è un processo in corso e dove c’era stato un
tentativo di manomissione dei filmati (del ruolo delle telecamere e delle
immagini digitali in quello specifico frangente e, più in generale, in tutti
quei casi che dovrebbero fungere da deterrente per le brutalità delle polizie
ne abbiamo parlato nell’inchiesta sulla strage nelle carceri durante il lockdown).
Nella conclusione del suo discorso l’esperto di carcere cita
una frase di Elton Kalica (che ha iniziato il suo percorso di studi dietro
le sbarre diventando Dottore di ricerca in Scienze Sociali) e che racchiude
l’essenza malata dell’istituzione da ri-concepire dalle radici, intervenendo in
primis sui rapporti sociali: <<nell’attuale assetto sociale il
carcere è l’architrave per neutralizzare parte della popolazione vista come
nemica>>.
Non ci sono fondi sufficienti per garantire diversi diritti
basilari alle quasi 60 mila persone che vivono nelle prigioni italiane mentre,
al contrario, stiamo spendendo ingenti risorse per l’utilizzo di braccialetti e
altri dispositivi elettronici di controllo
che non sembrano incidere effettivamente sull’enorme problema del sovraffollamento,
e che invece potrebbero allargare <<a dismisura l’area del controllo
penale, fino a occupare spazi di tradizionale pertinenza dei servizi sociali>>,
come evidenzia un rapporto di Antigone dello scorso anno, basato su dati diffusi nel Regno Unito,
mentre per l’Italia non ne sono stati forniti abbastanza dalle autorità.
Bisognerebbe garantire i vari diritti, accesso
a Internet incluso (con le ovvie e dovute limitazioni) a tutta la popolazione
carceraria, prescindendo dalla logica premiale della concessione ed
elaborando una carta dei diritti digitali per i detenuti. Invece nelle
carceri vige un sistema “infantilizzante”, che va di pari passo con la scarsità
di risorse materiali e umane (e forse anche con la scarsa “voglia di lavorare”
di molti appartenenti al personale penitenziario), per cui per ogni minima
richiesta bisogna sempre compilare la famosa “domandina”...
Dopo aver parlato della mancanza di tecnologie che conduce
alla mancanza di diritti passiamo ad analizzare l’eccesso di tecnologia che
invece li mina (oltre al caso dei braccialetti elettronici), e che molto spesso
conduce a detenzioni arbitrarie e illegittime: Riccardo
Noury, portavoce di Amnesty International Italia, ha
presentato i risultati di due inchieste sulla sorveglianza digitale. La prima è
culminata nella campagna “Ban the Scan”
(“scansioni al bando”) per vietare l’uso, lo sviluppo e la vendita di
tecnologie per il riconoscimento facciale finalizzato alla sorveglianza di
massa.
 |
| Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia |
La campagna, avviata nel 2021, si basa su tre ricerche in
altrettante città: New York, Hyderabad ed Hebron. Decine
di migliaia di telecamere vengono usate, insieme a dati biometrici e immagini
tratte da altre “fonti” come i social network, in uno scenario “orwelliano” e
distopico che viola diversi diritti umani, a cominciare da quello della privacy
naturalmente: queste tecnologie espongono migliaia di persone ad arresti
ingiusti, insieme all’incremento di discriminazioni verso minoranze
e comunità marginalizzate, tramite delle tattiche intimidatorie
“automatizzate”. Parliamo di un campo legislativo scarsamente regolato o
sistematicamente violato, con la capacità di effettuare “pedinamenti digitali”
passo dopo passo, alimentando pregiudizi e minando seriamente la coesione
sociale delle democrazie, e fornendo precisissimi strumenti di repressione agli
stati più autoritari.
Il rapporto pubblicato
riguardo l’“apartheid automatizzato” di Israele è il più recente delle
tre città. La parola apartheid non è usata dalla ONG per enfatizzare il livello di gravità che ha raggiunto
l’occupazione Israeliana, ma è parte organica di una richiesta al Tribunale Penale Internazionale e a tutti gli stati per avviare una causa di crimini
conto l’umanità.
L’utilizzo delle tecnologie“Red Wolf” e “Mabat
2000” serve a restringere ulteriormente la possibilità di movimento dei
palestinesi nella città di Hebron, nei territori occupati della
Cisgiordania, e a Gerusalemme Est, capitale dello stato palestinese, limitando
il diritto al lavoro, allo studio, all’acceso a strutture mediche ma anche solo
a incontrarsi con i propri cari. La ricerca di Amnesty si è avvalsa
della collaborazione di un’altra ONG, Breaking The Silence,
formata da ex militari israeliani.
I software per il riconoscimento facciale e la raccolta di
dati, presenti sia sulle telecamere dei checkpoint che sulle app dei
soldati occupanti, si integra a una serie di strategie per rendere
impossibile la vita dei palestinesi, favorendo quella dei coloni e
schedando (senza consenso) in appositi database chi è stato “attenzionato”
dalle forze israeliane anche solo per aver partecipato a proteste pacifiche
(solitamente represse da agenti sotto copertura con un uso illegale della
forza). In base a questi dati viene deciso se una determinata persona può o
meno passare un posto di blocco, esponendola anche a detenzioni
arbitrarie non necessariamente nell’immediatezza del controllo, e
prefigurando un futuro cacotopico in cui i cancelli dei checkpoint saranno
completamente robotizzati, e in un presente in cui le telecamere di
sorveglianza poste su diversi pali vengono usate come dispositivo doppiamente
“panottico”, e quindi non solo dall’interno verso l’esterno, e quindi da un
punto di osservazione posto nel centro di uno spazio, ma anche dall’esterno
verso l’intwebi.
Non sarebbe certo la prima volta che tecnologie
particolarmente invasive sperimentate in Israele vengano poi adottate nel resto
del Mondo. Alcune telecamere, sostiene il rapporto, sono state fornite dalla
cinese Hikvision e dall’olandese TKH Security, per
poi essere distribuite dall’israeliana Mal-Tech: Amnesty ha
formalmente interrogato le prime due sulla concreta possibilità che le loro
tecnologie vengano usate violando i diritti umani, e mentre l’azienda neerlandese
ha negato di avere rapporti con l’azienda israeliana (nonostante sul suo sito
fosse presente un documento che affermava il contrario) quella cinese non ha
fornito alcuna risposta.
Anche l’uso di questi mezzi nella città indiana di Hyderabad,
violando tutta una serie di normative della democrazia più popolata del
pianeta, hanno funzionato come una sorta di gigantesco campo di prova e di
implementazione degli stessi. Le “molestie automatizzate”, come le
definisce l’organizzazione, danneggiano le comunità già stigmatizzate del
paese: musulmani, transgender, adivasi e i “pària”, l’ultima casta del sistema
socio-religioso induista.
Negli USA invece diverse città hanno messo al bando il
riconoscimento facciale per la sorveglianza di massa, ma non New York dove
Amnesty ha intentato una causa contro il dipartimento di polizia,
spiegando che la tecnologia ha amplificando le dinamiche razzializzanti
al suo interno.
Le telecamere si concentrano nelle aree dove ci sono meno
bianchi, e un utilizzo massiccio degli strumenti di identificazione e
repressione è stato registrato durante una serie di proteste, come quelle del
movimento Black Lives Matter.
Emblematico è stato il caso di Derrick “Dwreck” Ingram,
tenuto ostaggio nella sua casa assediata da droni, polizia armata fino ai denti
con unità cinofile e un elicottero, dopo che una sua foto di Instagram
era stata diffusa con la scritta “ricercato”: pare che fosse stato accusato di
aver urlato nelle orecchie di un poliziotto (e quindi un reato minore) ed è
stato “riconosciuto” dal software circa due mesi dopo l’evento, nel 2020. Alla
fine i poliziotti, dopo averlo terrorizzato tentando di distruggere la porta di
casa, hanno lasciato il luogo perché non avevano un mandato.
Il riconoscimento facciale non è usato solo dalla polizia
newyorkese, ma anche da alcuni proprietari immobiliari per sorvegliare la
comunità afroamericana, oltre a dover sottoporsi alla scansione facciale per
entrare nelle proprie abitazioni.
È possibile firmare una petizione per unirsi al grido di “Banthe Scan”!
Sulla sezione del sito della ONG, "Amnesty Decoders" è presente una
piattaforma dove migliaia di “volontari digitali” possono contribuire a
diversi progetti, tra cui quello di una mappatura dei luoghi della “Grande
Mela” in cui è più probabile che si venga “scannerizzati”, un esempio virtuoso
di come usare collettivamente le “tech”.
Invece un esempio di un uso sbrigativo e controverso delle
intelligenze artificiali da parte della ONG è quello attuato dalla sua sezione
norvegese: hanno usato un generatore di immagini per ricordare le brutalità
della polizia in Colombia nel 2021, evitando di usare fotografie reali per
preservare l’anonimato di chi era nelle proteste.
Il fine era legittimo, ma il mezzo ha alzato un polverone mediatico perché,
nelle parole dello stesso Noury, <<non si può sostituire il lavoro dei
fotografi e quando non si possono mostrare i volti lavoriamo con la grafica o
con i disegni>> mentre quello <<è stato un tentativo goffo,
è uscita fuori una bandiera della Colombia che sembrava quella spagnola>>.
Tuttavia pensiamo che gran parte della stampa mainstream, oltre a criticare
queste problematiche “grafiche” e comunicative, potrebbe concentrarsi su ciò che accadde in Colombia nel Maggio del 2021,
quando morirono più di venti persone, 65 sparirono nel nulla, e si registrarono
più di 140 abusi (9 di tipo sessuale) insieme a più di 760 arresti arbitrari.
Adesso ci allontaniamo dalle contenzioni fisiche e digitali,
dai confini intangibili e virtuali imposti dalla cultura e rafforzati da certe
tecnologie per avvicinarci a quelli imposti dagli stati.
Lorenzo Pezzani
è un architetto e ricercatore che anima una serie di progetti ruotanti intorno
alla violenza dei confini, denunciano gli abusi di chi dovrebbe salvare,
e non reprimere le persone in movimento, contribuendo concretamente alla loro
salvezza, come fa Watch the Med Alarm Phone.
Attualmente è tra i fondatori del progetto “Border Forensic”, che raccoglie l’eredità di “Forensic Oceanography”.
L’associazione no-profit conduce ricerche per comprendere e combattere il
<<regime di confine militarizzato imposto dagli stati europei lunghe
le frontiere marittimi dell’UE>>.
Il termine “forensic” potrebbe essere tradotto
letteralmente come “forense”, ma nell’accezione inglese indica le particolari
pratiche poliziesche/investigative che si
effettuano in laboratorio con l’ausilio delle “scienze dure”: in pratica gli
attivisti hanno trasformato una pratica
poliziesca in una contro-egemonica <<in una maniera
schizofrenica, standoci dentro e contro allo steso tempo>>.
Lo fanno basandosi principalmente su dati “aperti”, come
quelli ricavati da mappe, immagini satellitari, sensori, registri dei tracciati
aerei e navali, che vengono incrociati con interviste, testimonianze, filmati e
dati raccolti dalle ONG che svolgono attività di “Ricerca e Soccorso”
(SAR). E non lo fanno per sorvegliare i confini ma per denunciare gli abusi
della sorveglianza sui confini, oltre che per <<garantire il
diritto all’opacità che riguardano pratiche di attraversamento non autorizzate>>.
Un esempio delle loro “investigazioni autoprodotte” e di
“contro-uso delle tecnologie” consiste in un articolo web interattivo
realizzato con “Human Rights Watch” intitolato: “Complicità
Aeromobile, la sorveglianza Aerea di Frontex permette abusi”.
Analizzando i tracciati di velivoli pilotati a distanza e non, incrociati con
una serie di testimonianze, sono riusciti a presentare evidenze sul fatto che i
mezzi utilizzati dall’agenzia europea non vengono utilizzati per portare al
sicuro vite umane, ma supportano la sedicente guardia costiera libica
per riportare illegalmente i migranti in un paese dove i diritti umani vengono
calpestati sistematicamente, a vantaggio di chi gestisce i lager detentivi e
lucra sui viaggi della speranza con soldi dei contribuenti europei.
In particolare si è notato che un aereo pilotato a distanza
si muoveva lungo una serie di traiettorie prestabilite. Quando avvistava una
barca deviava da queste e successivamente i guardiacoste-miliziani libici (con
addestramento e mezzi navali forniti dall’Italia e altri paesi europei, tra
l’altro) intervenivano “magicamente” per riportare i migranti nell’inferno
libico, compiendo interventi che altrimenti non sarebbero stati alla loro
portata.
Altro progetto avviato dall’associazione è intitolato “Hostile
Environment” nel Regno Unito. Si fanno ricerche e si denunciano una
serie di metodologie di sorveglianza dall’interno dei confini: si chiede
a insegnanti, impiegati di banca, personale sanitario e a tutti i cittadini di
condividere dati con l’Home Office britannico su potenziali migranti
formalmente irregolari, trasformando gli abitanti “spioni” in una specie di
guardacoste e poliziotti dediti a combattere e criminalizzare i fenomeni
migratori (praticamente un processo di “poliziazzazione” di civili). Quei dati
vengono poi incrociati con degli altri presenti nei database governativi e,
tramite degli algoritmi, vengono studiati dei “pattern” di possibili
irregolarità.
Concludendo il suo breve e incisivo intervento, pone
l’accento sull’importanza della sensibilizzazione insieme allo sviluppo
di tecniche investigative “open source”, all’avvio di contenziosi
strategici nei tribunali per innescare cambiamenti normativi partendo da
singoli casi, alla cooperazione con altri attori non governativi e
comunità di migranti tramite <<strategie basate sulle arti e
l’architettura, che ci forniscono mezzi fondamentali di analisi
visuale e spaziale>>, e quindi di pratiche collettive finalizzate
all’attivismo e alla ricerca in favore del rispetto dei diritti umani, con
l’orizzonte ideale che è l’abolizione dei confini.
Si è parlato di politiche
sulle migrazioni , con una particolare attenzione ai “confini
interni” allo spazio di Schengen, anche nell’ultimo intervento più
“accademico” (e onestamente non nascondo che è stato abbastanza difficile
seguirlo e quindi, sperando di non riportare inesattezze, siamo disponibili per
qualunque richiesta di rettifica), quello di Chiara
Loschi, Dottoressa di ricerca in scienza politica e relazioni
internazionali che ha realizzato numerosi studi e lavorato per diversi progetti
nell’ambito migratorio “Mediterraneo”, tra cui uno sulla gestione europea della crisi libica , un altro che indaga le relazioni tra la cooperazione delle agenzie europee eil rispetto dei diritti umani,
e anche uno sui cosiddetti “hotspot” per migranti.
La relatrice ha esposto la principale argomentazione dello
studio realizzato con la già citata Annalisa Pelizza e pubblicato ad Aprile, dal titolo (tradotto): “Raccontare ‘storie più
complesse’ sull’integrazione europea: come una prospettiva socio-tecnica può
aiutare a spiegare la continuità amministrativa nel Sistema di Asilo Comune
Europeo”.
Le narrazioni mediatiche, tendenzialmente allarmistiche,
parlavano di “crisi migratoria” da molto tempo prima della dichiarazione
dello stato di emergenza del governo Meloni, ma la studiosa spiega che si
tratta in realtà <<di una crisi
delle politiche europee>>, con un bisogno di riforme che
non avanza e con “ricollocazioni” extralegali che continuano.
Viene dunque evidenziato un paradosso: le pratiche
amministrative vanno avanti mentre è in una fase di stallo l’attività politica del
sistema di accoglienza europeo CEAS (Sistema europeo comune di asilo)
e quindi del cosiddetto “sistema di Dublino”, secondo cui le richieste
di asilo devono essere esaminate nel primo paese di ingresso, senza meccanismi
di compensazione per il carico di lavoro per le nazioni in cui si registrano i
principali flussi migratori.
Succede dunque che paesi come l’Italia e la Grecia respingono
illegalmente le persone in movimento verso altri stati, tendenzialmente quelli
del Nord-Europa che, a loro volta, avviano delle procedure d’infrazione.
I “caratteristici” paesi d’entrata dovrebbero raccogliere
nell’archivio European dactyloscopie (non esplicitamente menzionato nel
lavoro di ricerca), le impronte digitali di richiedenti asilo e delle
persone colte nel momento del passaggio formalmente irregolare tra le
frontiere. Oltre alla raccolta di dati biometrici esiste anche un
sistema per raccogliere dati sullo stato di salute dei migranti (che è
invece al centro dello studio), focalizzato in particolare sugli aspetti
psicologici/psichiatrici dei richiedenti, e si chiama MiMOSA. Il
fine principale di questo strumento, gestito dall’OIM (Organizzazione
internazionale per le migrazioni), è quello di <<mitigare gli
effetti delle preoccupazioni degli stati membri e del rifiuto di ricollocazioni
basati su ragioni di salute pubblica>>. Il funzionamento di questo
database, argomentano le studiose, è un esempio di come nonostante la
situazione di stallo delle politiche dell’UE e la mancanza di fiducia tra i
diversi paesi europei, l’azione amministrativa acquista una dimensione
preponderante e in qualche maniera compensa una serie di mancanze e
instabilità politiche, rafforzando l’operato di enti non statali come l’OIM che
assume il ruolo di mediatore per le ricollocazioni tramite lo standard
assicurato dal sistema MiMOSA, definibile come un’infrastruttura di dati
sanitari.
Nella conclusione dello studio le autrici spiegano che il loro
intento è, in un certo senso, politicamente “asettico”, dato che si occupano di
descrivere le complesse relazioni tra il fenomeno migratorio e le
infrastrutture di dati, e che le evidenze presentate dovrebbero servire a
elaborare nuovi studi e domande di ricerca <<sul rispetto dei diritti
umani internazionali e sui principi della protezione dei dati>> oltre
che sulle evoluzione del sistema di accoglienza europeo. Infatti il ruolo di
queste infrastrutture virtuali, così come quello delle tecnologie in
generale, influenza lo sviluppo degli stati, così come lo hanno fatto le infrastrutture
fisiche: l’esperta di politiche migratorie ha voluto sottolineare che,
negli ultimi secoli, il modello di integrazione europea si è basato proprio su
infrastrutture come le reti ferroviarie, e quindi oggi il campo delle infrastrutture
“intangibili” merita una profonda attenzione.
ALTRI SPUNTI SPARSI E RISORSE ONLINE “DA SPULCIARE”
Tantissimi altri “input” sono arrivati anche dagli stand, dalle talk finali più
“rilassate” e dalle registrazioni di alcuni dei tavoli presenti sull’archivio delsito di RTT. Invitando nuovamente chi non ha potuto partecipare a
“spulciarsele”, prima di concludere riporto in maniera fulminea altri argomenti
che mi hanno particolarmente colpito e che ho cominciato ad approfondire:
partendo dai “dati” si è parlato della stessa nozione di
“dato”, di quella di “dato
di genere” e di “contro-dato”, di come proteggere i propri dati
personali e delle pratiche di autodifesa digitale nella giungla
anarco-capitalista, un “far west” in cui i “banditi” delle big-tech hanno le
pistole più potenti e scorrazzano con troppa facilità…
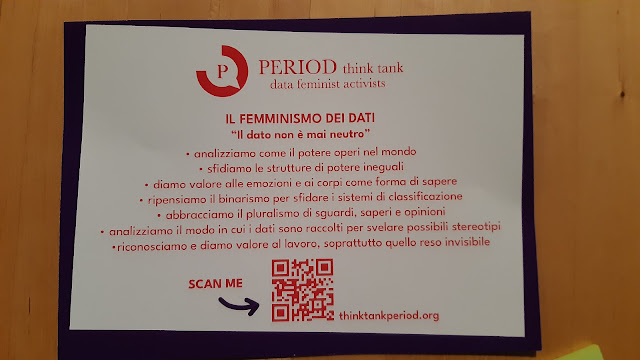 |
| Il volantino di Period Think Tank |
Altra definizione cruciale è legata al mondo del lavoro: “tech
worker” non è solo chi scrive programmi, chi cura il web-design di un sito
aziendale, chi si occupa di grafica o fa il sistemista, ma è anche chi consegna
pasti in bicicletta guidato da un algoritmo o chi lavora al videoterminale in
un call-center.
 |
| Il banchetto di Tech Workers Coalition |
Sempre restando nell’ambito lavorativo ho appreso un nuovo
termine, “cognitario”: si tratta di precarə con competenze specializzate
e sottopagate dal “mercato del lavoro”. E poi ci sono i “bullshit jobs”,
o “lavori del cacchio”, definizione introdotta da David
Graeber.
Altro tema cruciale per lo sviluppo fisico e cognitivo delle
nostre menti è quello dell’impatto delle tecnologie sulla capacità di
attenzione e concentrazione nel mantenere una conversazione, o magari nel
leggere un libro cartaceo, e quindi sulle nostre percezioni sensoriali e sui
processi cognitivi.
Oltre agli usi e agli impatti negativi ci sono anche quelli
positivi delle tecnologie: è vero che i droni vengono usati per
reprimere illegalmente le migrazioni ma, per esempio, possono essere usati per
ridurre o rilevare fonti di inquinamento e denunciare gli abusi ambientali.
Infine c’è una prospettiva che ritengo illuminante e che rompe
con le visioni dominanti dell’antropocentrismo: sul pianeta non ci sono
solo essere senzienti (le varie specie animali, umani inclusi) e vegetali
(forse anche piante, insetti e microrganismi potrebbero essere inclusi nel
novero degli esseri con una qualche forma di coscienza, anche se non sono
dotati di un sistema nervoso centrale come il nostro), ma anche componenti inorganiche
e, infine, le macchine (sia fisiche, come i macchinari di una fabbrica,
sia virtuali, come le intelligenze artificiali e gli algoritmi). Queste quattro
dimensioni sono profondamente interconnesse, e il “lavoro non salariato” svolto
dalle componenti non umane della biosfera non è di solito preso in
considerazione: ad esempio possiamo respirare grazie al “lavoro” delle
piante che producono ossigeno, oppure il pericolo della sopravvivenza e del
“lavoro” delle api è collegato a quello della riproduzione di molti
vegetali, o ancora, possiamo usufruire del petrolio (anche se ovviamente
dovremmo farne a meno) grazie a processi “non salariati” di decomposizione
di materiali organici che si realizzano in milioni di anni. Questa
prospettiva “globale” potrebbe essere sintetizzata come un’estensione della
teorie del materialismo storico a tutti i processi di “Gaia” e nell’immediatezza dovrebbe spingerci ad anteporre il tema del “green first”
(ma non in maniera esclusiva) a tutti gli altri impegni sociali e politici.
LE LOCATION “NON CASUALI”, L’ACCOGLIENZA E IL LAVORO DI
CURA
La tre giorni è stata
possibile non solo a chi ha viaggiato lungo tutto lo stivale per animarla, ma
soprattutto grazie al lavoro di cura gratuito di tutt# gli/le attivist#
che hanno montato le attrezzature, che hanno fatto le pulizie, che hanno
cucinato (buonissime le opzioni vegane sempre presenti, slurp!),
che hanno accolto nella propria casa i/le "viandant#", allo spazio per i/le più piccole/i e così via.
Nonostante qualche “fisiologico” problema logistico per una
prima edizione, in particolare nella palestra popolare il suono delle diverse
“talk” si accavallava (cosa che un attivista/partecipante neurodivergente ci ha
tenuto giustamente a sottolineare) posso immaginare che l’organizzazione
dell’evento, assemblee preparatorie dei diversi tavoli di discussione incluse,
ha richiesto tantissimi sforzi che mi pare siano altrettanto “ripagati”
socialmente.
 |
| La palestra popolare del TPO |

In merito a ciò è più
che necessario spendere qualche parola sulle "location", che sono
anche degli spazi di lotta.
Partiamo dal "Teatro Polivalente Occupato",
nato nel 1995: <<Dopo un primo
sgombero dagli spazi dell'Accademia delle belle arti nel 2000, fu un'ex
fabbrica di acquari ad essere occupata fino al 2007. Da quell'anno ad ora il
Tpo ha sede in via casarini 17/5. Queste le mura che lo hanno protetto>>,
si legge sul sito che definisce un Centro Sociale come<<uno spazio indefinibile e non recintabile
per concetto, che ha nel proprio DNA una principale attitudine politica. Si
distingue nell’agire politico quotidiano, nella creazione di dibattito e
conflitto, divenendo poi un contesto sociale aperto, diffuso e partecipato.
Questa l’idea che lo illumina. Il Tpo è antifascismo e antisessismo, è
comunicazione e cultura. Il Tpo è un artigiano paziente intento a plasmare
pratiche di diritti e libertà>>
Parlando con Lino,
che ci ha calorosamente accolto, abbiamo compreso (se abbiamo compreso male questo
o qualunque altro concetto sopraespresso comunicatecelo, la pseudo redazione si
attiverà quanto prima e rettificherà ;) che sostanzialmente un nucleo di
militant# ha esteso le sue pratiche, le sue energie e i suoi saperi dal TPO al Làbas,
definibile come "Municipio Sociale", concetto affine a quello
del centro sociale ma che in un certo senso lo supera o quantomeno ne
rappresenta una possibile evoluzione, come spiegato sul quaderno dei Municipi Sociali: <<i municipi sono spazi aperti e, forse, non sono più i centri sociali di
una volta. Centri sociali, per dirla in breve: luoghi con cancello o portone da
aprire e chiudere tutti insieme, collettivo di gestione, assemblea settimanale,
quadro ideologico tutto sommato ben definibile, contesto culturale di
provenienza dei suoi frequentatori abbastanza simile. Di tutte queste
definizioni, parziali e abbastanza riduttive, una però è importante e
suggestiva. L’immagine del cancello. L’indicazione del municipio sociale ci ha
stimolati in questi anni a vedere i nostri spazi non come spazi da gestire, ma
come spazi da autogovernare con le decine di persone che li
attraversano. Non più lo spazio del collettivo, ma lo spazio della ricerca
politica di nuove forme di organizzazione. In questo senso, una prima
differenza con i centri sociali degli ultimi anni risiede nel fatto che il
municipio sociale, per sua conformazione o perché tende ad esserlo, è uno
spazio sempre aperto, però non aperto da un collettivo gestore che porta
all’esasperazione la “sostenibilità della militanza” nell’essere continuamente
presente nello spazio. Aperto da forme di soggettività diverse da quelle che
hanno aperto i primi centri sociali. Aperto anche solo per fare un corso di
italiano, una visita medica o un corso di informatica. Aperto per progetti
politici espansivi e tendenzialmente interdipendenti. Uno spazio in cui
i soggetti sono una parte, autonomi, ma anche interdipendenti. Il centro
sociale era un progetto politico in sé, il municipio sociale invece ne contiene
molti, di progetti. Interdipendenza, dunque, e non pura autonomia. Anche
se sì, siamo ancora autonomi. (...) Autonomi perché, per esempio, la
sfida per l’autonomia è la più grande che si pratica in un doposcuola o in
contesti dove il circolo vizioso della povertà non fornisce alcun elemento di
riscatto, singolare o collettivo.
Essere autonomi fa parte del nostro DNA di soggetti eretici. Un DNA che
sta subendo delle modificazioni, trasformazioni che però proviamo sempre ad
acquisire in senso espansivo, materialista, gioioso.
Da autonomi, allora, ci interroghiamo sull’interdipendenza di e tra
quelli che abbiamo iniziato a chiamare municipi sociali. Il concetto di
Autonomia gioca un ruolo molto importante nel saper cogliere le sfide
dell’interdipendenza presentate dai Municipi sociali>>.
Insomma, è uno spazio
autogovernato da chi lo attraversa, uno spazio che non sacrificando la propria
autonomia, le pratiche dell’autogestione e la propria indipendenza, non
dimentica il suo rapporto di interdipendenza con altri settori della società
(in particolare quelli più marginalizzati e “difficili”), provando a mutarla insieme a quei “pezzi” di comunità, trascendendo
l’ambito di chi è già politicamente “impegnat*” e misurando la forza
dell’impatto che si vuole ottenere.
Degno di menzione è
anche un terzo spazio, H.O.ME. Hub di Organizzazione Meticcia
(sede dell’ex Caserma Masini e prima sede di Làbas fino al suo
sgombero nel 2017), dove sono stati ospitat# alcun# “pellegrin#” della
"riconquista" tecnologica: lo stabile è stato ri-occupato per
rivendicare il diritto all'abitare, una forma di lotta affine a quella di chi
in questi giorni sta piantando le tende davanti alle università,
reclamando spazi che una volta abbandonati avviano dei meccanismi in favore del
profitto di speculatori e “palazzinari” vari, lasciando letteralmente molte
persone in mezzo a una strada, tutelando gli interessi meramente economici e
tradendo invece uno dei diritti più basilari dell'essere umano, quello di un
tetto sopra la testa.
VERSO RECLAIM THE TECH 2024
Nell’assemblea plenaria finale è emersa la volontà di non
auto-etichettarsi come “quelle/i del RTT” ma piuttosto di definirsi con un tanto
generico quanto potente e responsabilizzante “noi”, quelle persone che
nella tre giorni non solo hanno parlato di tecnologia, ma hanno cominciato a
stabilire relazioni e a creare delle connessioni in un “social network”, nel
senso letterale di “rete sociale”.
“DIREZIONAMO” L’USO DELLE TECNOLOGIE, PROGETTIAMONE DI
NUOVE REALMENTE “SOSTENIBILI”, SVILUPPIAMO CONSAPEVOLEZZA, E FACCIAMOLO DA
SUBITO!
Oltre a ricordare ancora una volta che per qualunque
puntualizzazione, critica, commento, apprezzamento, proposta, richiesta di
aggiungere o rimuovere qualcosa o richieste di altro genere basta contattare la
pseudo-redazione (con qualunque mezzo, social oppure a-social... tranne
piccioni viaggiatori, perché siamo seriamente contro lo sfruttamento di altri
essere senzienti, uman# inclus#) che si attiverà quanto prima, voglio ribadire
che questi tre giorni sono stati davvero fruttuosi: oltre all’interesse per la
materia “specifica” e allo stesso tempo eterogenea del fest, è un tipo di
quelle occasioni in cui si respira voglia di cambiamento, si intessono
rapporti ma anche, banalmente, si discute di “politica” (non
necessariamente “partitica”) a 360 gradi e, ancora più banalmente,
in questo periodo di abbrutimento comunicativo-mediatico, si discute!
Ho imparato tantissime cose nuove, ho cominciato a ragionare
su questioni che non avevo mai considerato o ad osservare il mondo digitale da
altre prospettive, ho continuato ad “affinare” la mia identità politica e di
attivista, e anche per la realizzazione di questo post ho attivato dei processi
conoscitivi fondamentali, proprio grazie ai molteplici “input” che si sono
impattati con la mia mente dopo la trasferta bolognese: estendiamo queste
prassi comunitarie, autogestite, di dibattito e “intellettuali” in tutti gli
ambiti della nostra società!
Le tecnologie possono renderci liberi ma possono essere usate
per reprimere e limitare le nostre libertà: con l’avvento del web, per esempio,
si pensava che avremmo avuto più possibilità di comunicare, e le abbiamo,
mentre è più dubbia la possibilità di essere ascoltati o letti, e quindi che le
nostre comunicazioni arrivino ad altr#, al di là del loro valore sociale e del
potenziale di miglioramenti... Inoltre anche chi ci vuole controllare e
comandare ha più possibilità di farlo grazie a Internet...
I diversi tipi di tecnologie possono essere progettati o
usati per farci avvicinare a un mondo ideale ed equo, oppure possono farci sprofondare in scenari distopici e apocalittici:
la direzione che la comunità umana prenderà e che sta già prendendo dipende
anche da ognunə di noi, dal nostro impegno nel “piccolo” quotidiano, dalle
azioni che vanno a determinare i “massimi sistemi”.
Con questo modesto post spero di aver dato un
contributo, seppure in minima parte, a queste battaglie, svolgendo il mio compito
principale di “scriba digitale”: a così tanti spunti teorici devono seguire
molti altri fatti pratici, del resto sono fermamente convinto che teoria e
pratica vanno di pari passo, si alimentano a vicenda... Riprendo le parole di
Lilia Giugni auto-invitandoci ad allenare e a non fare atrofizzare il “muscolo
dell’utopia”, insieme, per portare l’immaginazione radicale al potere.
Scribha Kino AKA Analfabeta Informatico
Funzionale
ultima modifica 12:12 23/05/2024
Se i contenuti che hai trovato tra queste pagine digitali ti sono stati in qualche maniera utili sostienici condividendoli tramite passaparola, via "social-media alternativi” (o per meglio dire sul "Fediverso") o anche seguendoci sui “social asociali” (se non hai deciso di boicottarli del tutto i link si trovano sotto).
Realtà editoriali come questa fanzina/rivista tendono a essere penalizzate dalle logiche di mercato, dagli algoritmi e da chi li programma, per questo è fondamentale il tuo sostegno!
Per qualunque critica, apprezzamento, richiesta, proposta o commento: puoi usare il modulo dei commenti qui sotto, mandarci una mail o tramite messaggio/tag sugli altri canali (no piccioni viaggiatori: siamo contro lo sfruttamento di altri essere senzienti).


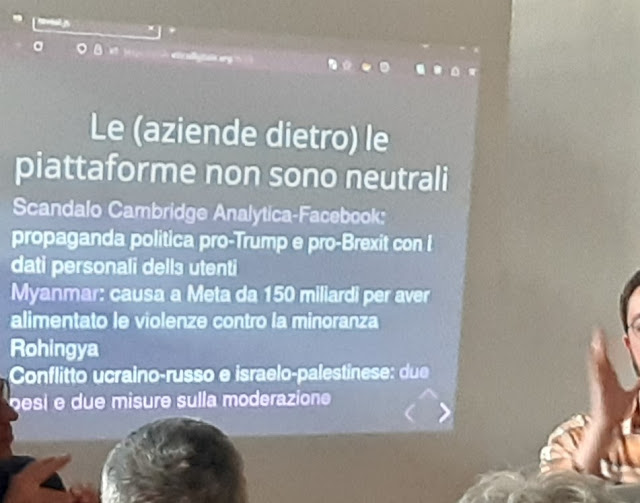
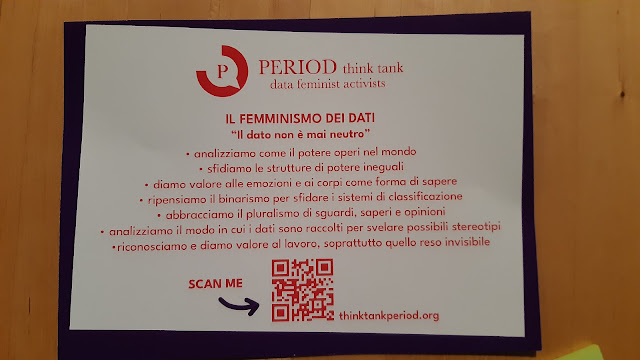









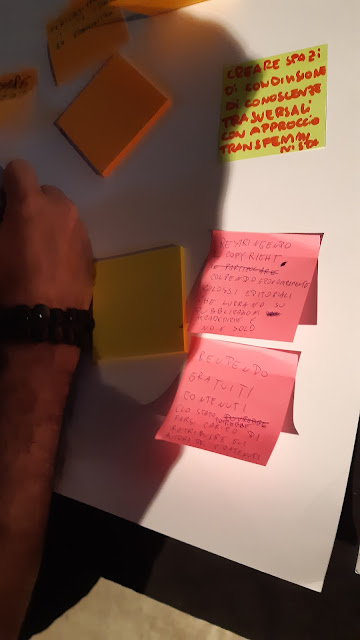










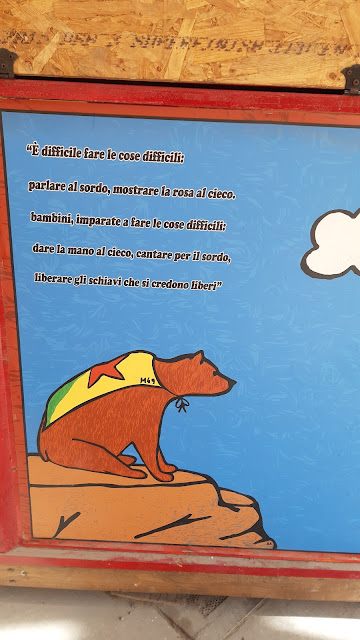


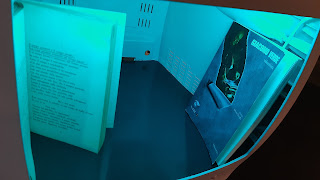



Nessun commento:
Posta un commento